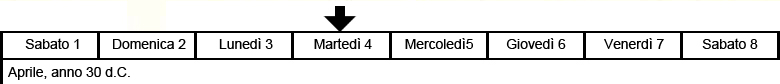
Un maestro che non cerca fama
15 Ottobre 2005 Anno A
Matteo 22,15-21
Riferimenti : Isaia 45,1.4-6; Salmo 95; 1
Tessalonicesi 1,1-5b
In quel tempo, i farisei [...] mandarono a Gesù
i propri discepoli a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la
via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in
faccia ad alcuno. Dicci dunque il tuo parere: È lecito o no pagare il tributo a
Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché mi
tentate? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro.
Egli domandò loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?». Gli risposero:
«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare
e a Dio quello che è di Dio».
A Gerusalemme Gesù è coinvolto
in una serie di dibattiti che chiamano in causa i gruppi più rappresentativi del
giudaesimo. Le risposte di Gesù agli interrogativi che gli vengono posti
mostrano la sua totale indipendenza di giudizio nei confronti delle correnti
culturali dominanti. Un'indipendenza di giudizio che dovrebbe essere la
prerogativa del cristiano di ogni tempo. Certamente tutto il peso del racconto
evangelico (Mt 22,15-21) cade sull'affermazione: «Rendete a Cesare quello che è
di cesare e a Dio quello che è di Dio». Ma prima soffermiamoci su un particolare
non privo di importanza. L'episodio pone due personaggi a confronto: Gesù e gli
interroganti. Due ritratti completamente diversi. Gesù - colto qui nella sua
struttura umana - è definito un maestro «veritiero», che insegna la via di Dio «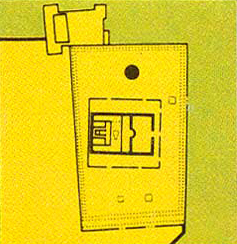 secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo
franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è
condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso
sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,
malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal
desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e
di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole
e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto
inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce
l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,
finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma
veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a
Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e
quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di
coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm
13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano
pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.
Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio
quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non
può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per
intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio
ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della
libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio. secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo
franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è
condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso
sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,
malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal
desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e
di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole
e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto
inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce
l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,
finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma
veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a
Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e
quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di
coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm
13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano
pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.
Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio
quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non
può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per
intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio
ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della
libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio.
|
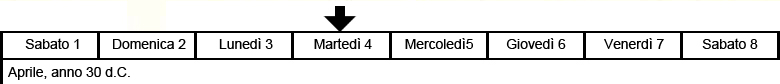
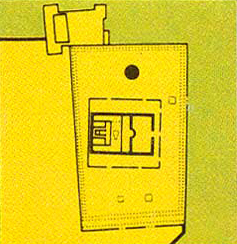 secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo
franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è
condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso
sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,
malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal
desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e
di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole
e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto
inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce
l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,
finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma
veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a
Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e
quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di
coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm
13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano
pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.
Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio
quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non
può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per
intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio
ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della
libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio.
secondo verità» e che non «guarda in faccia nessuno». Un uomo
franco, lineare, tutto d'un pezzo. Non dice ciò che gli è utile, non è
condizionato dal consenso e dalla popolarità: dice ciò che è vero, comunque esso
sia. Tutto il contrario è la figura dell'interrogante: un uomo contorto,
malizioso, capace di fingere per trarre in inganno. La sua domanda non nasce dal
desiderio di sapere né gli interessa la verità. Il Vangelo parla di «malizia» e
di «ipocrisia». Il primo termine (poneria) indica una malizia consapevole
e furba, che sgorga dall'interno: non una cattiveria casuale, un atto
inconsulto, ma una scelta abituale, una logica di vita. Il secondo definisce
l'attore, l'istrione: recita sulla scena parti che non riflettono la sua vita,
finge sentimenti che non prova. Dentro è in un modo e fuori in un altro. Ma
veniamo al punto. Il detto di Gesù risulta di due parti. La prima («date a
Cesare quello che è di Cesare») riconosce che ci sono i diritti dello Stato e
quando lo Stato rimane nel suo ambito questi diritti si tramutano in doveri di
coscienza. È significativo, ad esempio, che Paolo scriva ai cristiani di Roma (Rm
13) sollecitandoli a pagare le tasse e a rispettare le autorità (che pure erano
pagane). Anche se non gestito dai cristiani, lo Stato ha i suoi diritti.
Tuttavia lo Stato non può arrogarsi diritti che competono solo a Dio («e a Dio
quello che è di Dio»), il che significa che non può assorbire tutto l'uomo, non
può sostituirsi alla coscienza. Il cristiano rifiuta di far coincidere per
intero la sua coscienza con gli interessi dello Stato. Afferma il primato di Dio
ed è perciò - in radice - un possibile «obiettore di coscienza». La radice della
libertà di coscienza è il riconoscimento del primato di Dio.