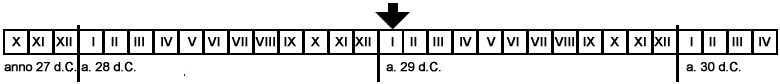 Quando compassione è condividere
Quando compassione è condividere
11 Giugno 2005 Anno A
Matteo 9,36-10,8
Riferimenti : Esodo 19,2-6a; Salmo 99; Romani 5,6-11
In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne
sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore.
Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi!
Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!".
Chiamati a sè i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità. [...] Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti:
"Non andate fra i pagani e non entrate
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa
d'Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite
gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni.
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date".
"Vedendo le folle": lo sguardo
di Gesù si sposta senza soluzione di continuità dalle infermità fisiche della
folla al suo disorientamento. Egli vede "folle stanche e sfinite, come pecore
senza pastore", dunque bisognose non soltanto di salute, ma anche di direzione e
di senso.
"Vedendo le folle sentì compassione": è questo il sentimento che spinge Gesù a
occuparsi delle folle malate e disorientate. La compassione è un sentimento che
dice una profonda e interiore partecipazione. Il vocabolo greco fa riferimento all'amore materno, il grembo. Si tratta di un amore viscerale, ostinato, che
quasi non vede ragione, prescindendo da ogni valutazione di merito. Gesù ama la
folla e basta.
Il comando  di Gesù di non andare tra i pagani e di non entrare
nella città dei samaritani sembra limitare l'orizzonte alla missione. Certamente
è un tratto che va compreso nella situazione storica del momento. Un tratto
superato, sembrerebbe di concludere. Ma non è del tutto così se lo si guarda
bene: almeno due tratti, infatti, mantengono intatta la loro freschezza. Il
primo è che non si parla semplicemente di "casa d'Israele", ma di "pecore
perdute". La prima espressione dice il limite, ma la seconda dice la vera natura dell'universalità evangelica, che non sta semplicemente nell'andare dovunque, ma
nella ricerca dei perduti. Gesù stesso non è uscito dai confini di Israele.
Missione non è correre dovunque e arrivare dappertutto. L'essenziale è far
maturare, anche in un luogo solo, quei valori che hanno in sè una carica di universalità. L'essenziale è essere, dovunque ci si trovi, un segno dell'amore
di Dio per tutti, sia pure di fronte ad un uomo solo. di Gesù di non andare tra i pagani e di non entrare
nella città dei samaritani sembra limitare l'orizzonte alla missione. Certamente
è un tratto che va compreso nella situazione storica del momento. Un tratto
superato, sembrerebbe di concludere. Ma non è del tutto così se lo si guarda
bene: almeno due tratti, infatti, mantengono intatta la loro freschezza. Il
primo è che non si parla semplicemente di "casa d'Israele", ma di "pecore
perdute". La prima espressione dice il limite, ma la seconda dice la vera natura dell'universalità evangelica, che non sta semplicemente nell'andare dovunque, ma
nella ricerca dei perduti. Gesù stesso non è uscito dai confini di Israele.
Missione non è correre dovunque e arrivare dappertutto. L'essenziale è far
maturare, anche in un luogo solo, quei valori che hanno in sè una carica di universalità. L'essenziale è essere, dovunque ci si trovi, un segno dell'amore
di Dio per tutti, sia pure di fronte ad un uomo solo.
Come quella di Gesù, anche la missione del discepolo è itinerante: "andando". E
il suo compito è indicato da cinque imperativi: il primo è il compito della
parola (predicare), gli altri quattro riguardano la liberazione dell'uomo dalle
sue sofferenze (guarire, risuscitare, mondare, cacciare i demoni). Un sesto
imperativo - e questo è molto significativo - non descrive più i compiti da
svolgere, ma il modo di svolgerli: "Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date". L'espressione greca dice la gratuità più assoluta. Gesù non ha mai preso
nulla, così deve fare anche il suo discepolo. Non soltanto non si chiede nulla
in cambio, ma nemmeno si guarda la dignità dell'ammalato o la particolare utilità della sua guarigione. Questa gratuità è la caratteristica essenziale dell'azione salvifica di Dio.
|
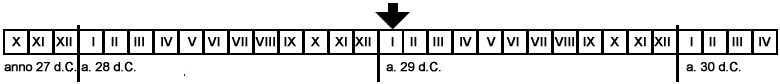 Quando compassione è condividere
Quando compassione è condividere di Gesù di non andare tra i pagani e di non entrare
nella città dei samaritani sembra limitare l'orizzonte alla missione. Certamente
è un tratto che va compreso nella situazione storica del momento. Un tratto
superato, sembrerebbe di concludere. Ma non è del tutto così se lo si guarda
bene: almeno due tratti, infatti, mantengono intatta la loro freschezza. Il
primo è che non si parla semplicemente di "casa d'Israele", ma di "pecore
perdute". La prima espressione dice il limite, ma la seconda dice la vera natura dell'universalità evangelica, che non sta semplicemente nell'andare dovunque, ma
nella ricerca dei perduti. Gesù stesso non è uscito dai confini di Israele.
Missione non è correre dovunque e arrivare dappertutto. L'essenziale è far
maturare, anche in un luogo solo, quei valori che hanno in sè una carica di universalità. L'essenziale è essere, dovunque ci si trovi, un segno dell'amore
di Dio per tutti, sia pure di fronte ad un uomo solo.
di Gesù di non andare tra i pagani e di non entrare
nella città dei samaritani sembra limitare l'orizzonte alla missione. Certamente
è un tratto che va compreso nella situazione storica del momento. Un tratto
superato, sembrerebbe di concludere. Ma non è del tutto così se lo si guarda
bene: almeno due tratti, infatti, mantengono intatta la loro freschezza. Il
primo è che non si parla semplicemente di "casa d'Israele", ma di "pecore
perdute". La prima espressione dice il limite, ma la seconda dice la vera natura dell'universalità evangelica, che non sta semplicemente nell'andare dovunque, ma
nella ricerca dei perduti. Gesù stesso non è uscito dai confini di Israele.
Missione non è correre dovunque e arrivare dappertutto. L'essenziale è far
maturare, anche in un luogo solo, quei valori che hanno in sè una carica di universalità. L'essenziale è essere, dovunque ci si trovi, un segno dell'amore
di Dio per tutti, sia pure di fronte ad un uomo solo.