|
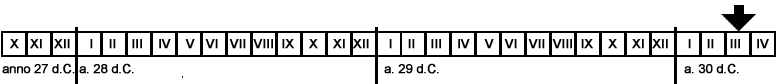 VIII
Domenica dopo Pentecoste VIII
Domenica dopo Pentecoste
22 luglio 2012
Marco10, 35-45
Riferimenti : Giudici. 2, 6-17 - Salmo 105 - Prima ai
Tessalonicesi2, 1-2. 4-12 |
| Lodate il Signore e invocate il suo nome,
proclamate tra i popoli le sue opere. Cantate a lui canti di
gioia, meditate tutti i suoi prodigi. Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e
la sua potenza, cercate sempre il suo volto. Ricordate le
meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua
bocca: voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo
eletto. È lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi
giudizi. |
Giudici. 2, 6-17 In quei giorni. Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli
Israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua eredità, a prendere
in possesso la terra. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di
Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano
visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in favore d’Israele.
Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci
anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres,
sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche
tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne
sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera
che aveva compiuto in favore d’Israele. Gli Israeliti fecero ciò che
è male agli occhi del Signore e servirono i Baal; abbandonarono
il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla
terra d’Egitto, e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli
circostanti: si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore,
abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. Allora si accese l’ira del Signore contro Israele e li mise in mano a
predatori che li depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In
tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male,
contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro
giurato: furono ridotti all’estremo. Allora il Signore fece
sorgere dei giudici, che li salvavano dalle mani di quelli che li
depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dèi e si prostravano davanti a loro.
Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore: essi non fecero così.
Israele vive un periodo difficilissimo mentre cerca di
insediarsi sul territorio che il Signore ha loro assegnato. Non c’è ancora una nazione d’Israele poiché vale
molto di più il rapporto tribale. Ognuno si colloca con le proprie possibilità e cerca i mezzi di sopravvivenza.
L’unità di popolo avverrà con la monarchia di Davide, attorno all’anno 1000 a C. Così il libro
dei “Giudici” fa riferimento ad un periodo precedente, che va dalla morte di Giosuè (circa il
1220-1200 a.C.) all'inizio dell'epoca monarchica. Vengono raccontate le avventure di alcuni
particolari capi del popolo, chiamati “giudici” che diventano capi tribù e cercano di affrontare i
nemici che attentano alla libertà e alle risorse delle tribù. Il periodo del racconto raccoglie,
complessivamente, fatti e battaglie di circa 160-180 anni. Scelto per le situazioni difficili che turbano la vita di una o
più tribù della comunità, ma non mai molte, il “Giudice” viene considerato un "liberatore", inviato
da Dio che finalmente ha accettato di ascoltare il grido di sofferenza. Così, diversi per esperienza e
per educazione, i “Giudici” sanno riportare il popolo alla sua riconquistata libertà e quindi
ricostruiscono un rapporto di pace con il Signore stesso. Nei vv 2,6-10 il testo si ricollega al libro di
Giosuè per indicare una continuità, sul filo dell’accordo compiuto con Dio nell'assemblea di Sichem (Giosuè 24,1ss) quando
tutto il popolo d'Israele, nelle sue 12 tribù, sancì il patto con Dio dopo aver ascoltato le
parole di Giosuè. Questi, ricordati i fatti della liberazione, aveva chiesto alle tribù la disponibilità a
servire Dio. Il popolo aveva risposto: "Noi serviremo il Signore” (v 21). L’autore di questo libro
garantisce che la generazione di Giosuè , con tutti quei
personaggi che avevano sperimentato la protezione di Dio nel deserto, avevano
tenuto fede all'impegno assunto (v 7). Ma, col passar del tempo (vv 11-17), la storia di Israele si
intorbida. Che cosa, infatti, è diventato, agli occhi di Dio, questo popolo, liberato attraverso Mosè? Lo
scrittore deve dare una risposta coerente alla fede ed ai costumi del suo tempo. Così egli compie una
interpretazione teologica: Dio ha abbandonato il suo popolo e non ascolta più il loro grido poiché Israele compie il male ed ha abbandonato il Dio
dell'Esodo per seguire altre divinità. E’ venuto meno al patto, tradendo il Signore e accogliendo le
stesse usanze, costumi, mentalità dei popoli entro cui si ritrova ad abitare. Essi facilmente si
lasciano ingannare e illudere dalle civiltà più evolute; essendo stati schiavi prima, ed ora contadini e
ignoranti pastori, sono affascinati dal benessere dei popoli della costa, molto più ricchi perché dediti
al commercio. Il benessere viene scambiato come un regalo ottenuto dagli dei
per il dono di offerte o loro carpito con pratiche magiche e usi pagani. Non è lontano il paradigma
del primo peccato dell’umanità, quello di Adamo ed Eva. La prima umanità segue le stesse
dinamiche, volendo raggiungere una propria potenza, immaginando poteri sovrumani. Nell’idolatria si
può ricattare Dio, lo si costringe, lo si obbliga alla fecondità della terra, degli animali e delle
donne. Si ritorna a parlare di schiavitù: "Furono depredati, furono
venduti ai nemici che stavano loro intorno ai quali non potevano più tener testa" (v 14). Il
Signore, tuttavia, finalmente si occupa della liberazione di questo suo popolo come ha sempre fatto e perciò
"fece sorgere dei Giudici" (v 16). Ma l’idolatria non scompare facilmente dall'orizzonte umano,
anche nell'ambito della vita quotidiana dei credenti di oggi. Idolatria significa mettere al
primo posto delle proprie scelte e della propria vita, ciò che non è Dio stesso, ciò che io o la società
riteniamo fondamentale:. Ci creiamo degli Assoluti. Ma la conclusione conduce alla guerra, alla
violenza, alla mancanza del necessario mentre cresce la ricchezza di classi privilegiate. |
Prima ai Tessalonicesi2, 1-2. 4-12 Voi stessi infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta
in mezzo a voi non è stata inutile. Ma, dopo aver sofferto e
subìto oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio
il coraggio di annunciarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte… come Dio ci ha trovato degni di
affidarci il Vangelo così noi lo annunciamo, non cercando di
piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo usato parole
di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia: Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la
gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati
amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri
figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non
solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci
siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro e
la nostra fatica: lavorando notte e giorno per non essere di
peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annunciato il vangelo di Dio. Voi siete
testimoni, e lo è anche Dio, che il nostro comportamento verso
di voi, che credete, è stato santo, giusto e irreprensibile. Sapete
pure che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo
esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di
comportarvi in maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno
e alla sua gloria.
Paolo si dimostra subito particolarmente affezionato a questa
comunità che lo ha accolto dopo le fatiche morali e fisiche subite a Filippi (At 16,19-40). Egli,
in questo testo, vuole sottolineare la chiarezza e l’onestà della proposta che fa del Vangelo e vuole
richiamare la gratuità della sua opera. Egli sa che il Vangelo è Gesù, dono del Padre, e la sua
vocazione deve prendere atto di testimoniare l’amore di Gesù, totalmente gratuito come dono del Padre. Paolo ha capito che la gratuità è la discriminante per scoprire
l’opera di Dio.. In tal modo aiuta anche noi un’analisi puntuale delle cose che Paolo enumera. - “Non ho cercato di piacere agli uomini e quindi non mi sono
permesso di adulare per aprirmi un varco nella comprensione e nella simpatia delle
persone; - Non ho cercato la gloria umana né da voi né da altri, pur
potendolo fare, in nome della mia autorità; - Sono stato amorevole tra voi come una madre che ha cura dei
figli; - Nel mio attaccamento a voi vi avrei dato anche gratuitamente
la vita; - Sempre per gratuità, ho lavorato duramente giorno e notte per
guadagnarmi il pane e non essere di peso a nessuno; - Con ogni mezzo e gratuitamente ho cercato di parlarvi, di
darvi esempio e di incoraggiarvi alla sapienza ed all’accogliere il Vangelo di Gesù
che io mi glorio di portare come una missione ed un compito. E’ la vocazione: che Dio mi ha affidato.
Mi sono sforzato di non piacere agli uomini ma a Dio che conosce il cuore di ciascuno”; - Il compito educativo non è solo materno ma ugualmente paterno
e Paolo sente che deve svolgere insieme questo ruolo, prezioso ed importante,
valorizzato particolarmente nel mondo ebraico, poiché è il padre che trasmette la Sapienza di Dio alle
nuove generazioni. - Per questo Paolo chiede ai cristiani ed anche a Dio di
essergli “testimoni del suo comportamento: “santo, giusto e irreprensibile"; - Paolo ricorda che “abbiamo esortato ciascuno di voi, e
incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna di Dio" (vv 11-12). - In questa prima lettera ai Tessalonicesi, Paolo utilizza la
parola greca “parresia” che significa: "parlare con chiarezza, coraggio e verità" e constata
che non è stata vuota la sua presenza né tanto meno inutile. Paolo, in tal modo, ha chiarito un atteggiamento fondamentale
dell'adulto credente: operare nella gratuità. E’ la caratteristica essenziale di Dio che Gesù ha
tradotto ogni giorno e che lo sforzo che la Comunità cristiana dovrebbe riproporre nei suoi criteri, stili,
proposte, operosità. Nel mondo è così stupefacente che insieme meraviglia, e crea diffidenza, sospetto
e dubbi di ambiguità. Eppure, anche se difficile, è un orizzonte da tenere continuamente presente. |
Marco10, 35-45 In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete
quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io
bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti». In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete
quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io
bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti».
Questo testo fa parte di quel capitolo 10 che costituisce una splendida
catechesi per l’adulto credente. Ritroviamo, a tratti, i brani che, per sé, andrebbero, comunque
ripensati insieme, anche se poi siamo obbligati ad analizzarli passo passo. Marco sta raccontando che Gesù è
in cammino con i suoi verso Gerusalemme ed ha raccolto qui cinque scelte fondamentali che il
credente deve far propri, seguendo Gesù maestro: E vanno affrontate tutte, in termini di gratuità
e di novità, nello stile di Cristo stesso: il matrimonio (Mc. 10,1 -12) , la emarginazione e le
sofferenze attorno a sé,accogliendo i piccoli e i poveri (13-16), il guadagnarsi il pane e quindi il
condividere il denaro (17-34), il potere che ogni persona ha acquisito (35-45), la ricerca religiosa che
riscopre Gesù uomo-Dio, Figlio di Davide (46-52).Gli apostoli hanno percepito, ormai chiaramente, quale sarà la conclusione di
questo viaggio. Non hanno il coraggio di fare altre domande, né di dissuadere Gesù poiché, quando
Pietro ha solo tentato di opporvisi, si è sentito dire: "Vai dietro di me, Satana, poiché non pensi
secondo Dio ma secondo gli uomini" (Mc 8,23). E tuttavia, tra i discepoli, serpeggiano varie domande
che li aprono, in pratica, sul futuro: "Dopo che Gesù sarà morto, chi avrà il potere in questa
comunità? Quando sarà risorto e nella gloria, chi avrà più potere?”Senza un minimo di discrezione, i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, si
presentano da Gesù con una richiesta: “Vogliamo che tu faccia ciò che ti chiediamo”. Il tono è
esigente, quasi espressione di un diritto. Gesù ne ha parlato, qualche tempo prima. “Dopo la
morte (8,38), sarebbe venuto nella gloria del Padre suo con gli angeli santi”.Ai due apostoli è rimasta in memoria “la gloria”, detta una volta sola ma che
non hanno dimenticato: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra».Vogliamo venire con te in cielo per giudicare, accanto a te, il mondo”.Quando Marco scrive, Giacomo e Giovanni hanno veramente affrontato una vita di
amore e di testimonianza in spirito di profonda gratuità (Giacomo ha già dato la vita
(At12,2) e Giovanni sta sostenendo con profondità e coraggio alcune comunità. Avevano maturato via via
il significato dell’essere con Gesù. Gesù chiarisce subito che non ci sono né carriere, né raccomandazioni, né
progressi per meriti. Il Regno di Dio non vive le stesse logiche di questo mondo e Marco tiene a
sottolineare che sono necessarie mentalità diverse che rifuggano dalla competizione per i primi posti. Scegliere Gesù non dà onore né grandezza e sbaglia completamente prospettiva chi
individua la sua dimensione religiosa per prestigio ed onore. Per spiegarsi ,Gesù utilizza due immagini: quella del calice e quella del
battesimo. Il calice rappresenta il destino, buono o cattivo di una persona e Gesù stesso
chiede al Padre:“Allontana da me questo calice” (Mc14,36) quando è nel Getsemani in attesa del
suo arresto. Il battesimo richiama l'immersione nelle acque della morte. L'uno e l'altro identificano le sofferenze della passione di Gesù che egli
affronta per portare speranza a tutti: Egli si fa servo, obbediente al Padre. Anche loro soffriranno ma il posto della gloria è dato gratuitamente dal Padre. La reazione degli altri è evidente, ma Gesù "li chiamò a sé" (è un momento
particolare di concentrazione e di rivelazione) e dice: "Verificate lo stile e i criteri della
gestione di ogni potere che esiste sulla terra. Ci sono poteri politici, economici, sociali, religiosi,
culturali". Essi manifestano un dominio, hanno pretese di privilegi, bisogno di cerimoniali, gerarchie e dignità
diverse. Ma tra voi non deve essere così. Il confronto è con uno schiavo: il livello più basso della
società a cui tutti danno ordini. Chi ha potere, si deve sentire servitore e ultimo della sua
comunità, cioè persona a disposizione. Gesù stesso, che è maestro, come i maestri del tempo, avrebbe diritto di essere
servito dai suoi discepoli; lo dovrebbero accudire, lavargli i piedi, perché, una volta promossi
rabbi, anch’essi si possano sentire serviti dai propri discepoli.. E invece è proprio Gesù che
laverà i piedi ai suoi discepoli, prima della cena nel Cenacolo (Gv13,4-5).Il compito dell'autorità, da chiunque essa sia esercitata, è perciò quello di
verificare, avendo responsabilità e sapienza, chi sia in maggiori difficoltà e di operare per il
"bene comune".
|
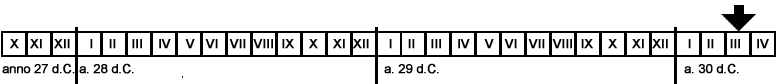 VIII
Domenica dopo Pentecoste
VIII
Domenica dopo Pentecoste  In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete
quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io
bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti».
In quel tempo. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che tichiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno
alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete
quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io
bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti».