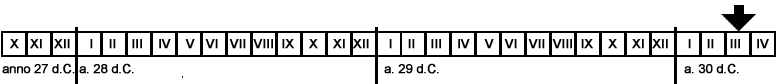
V Domenica di Quaresima
di Lazzaro
25 marzo 2012
Giovanni 11, 1-53
Riferimenti : Deuteronomio
6, 4a. 20-25 - Salmo 104 - Efesini 5, 15-20
Benedici il Signore, anima mia, Signore,
mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto. Tu stendi il cielo come una
tenda, costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il
tuo carro, cammini sulle ali del vento; fai dei venti i tuoi
messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. Hai fondato
la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare. L'oceano
l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
|
| Deuteronomio 6, 4a.
20-25 In quei giorni. Mosè disse: “Ascolta, Israele:
Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa
significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che
il Signore, nostro Dio, vi ha dato?”, tu risponderai a tuo
figlio: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci
fece uscire dall’Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto
i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro
l’Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece
uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai
nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di mettere in
pratica tutte queste leggi, temendo il Signore, nostro Dio, così
da essere sempre felici ed essere conservati in vita, come
appunto siamo oggi. La giustizia consisterà per noi nel mettere
in pratica tutti questi comandi, davanti al Signore, nostro Dio,
come ci ha ordinato”.
Il capitolo 6, nel libro del Deuteronomio, ha un fondamentale
significato per il popolo d’Israele: imposta
il contenuto della fede per tutto il popolo nel tempo (“Ascolta
Israele; il Signore è il nostro Dio 6,4), delinea la sua morale
nell’amore pieno verso Dio (“Amerai il tuo Dio con tutto il tuo
cuore 6,5), impegna nell’educazione dei figli per continuare
l’Alleanza. Nel capitolo precedente l'autore biblico ha
ricordato la legge, sintetizzandola nelle 10 parole di vita: i
10 comandamenti. Ma attorno a questi esistono moltissime altre
leggi che gli ebrei, con infinita pazienza, hanno cercato di
scandagliare, di ripensare, di elencare, di rendere concrete
nella loro vita. Si parla così di "precetti, istruzioni,
statuti" che propongono la sapienza di Dio nel suo popolo che
deve maturare e deve trasmettere. Secondo la riflessione
biblica, è questa la vera strategia per mantenere il benessere e
la pace. Incontriamo, qui, alcune parole
fondamentali: "ascoltare, osservare e ripetere", "domandare e
rispondere". È proprio dell'adulto l'attenzione alla Parola di
Dio ("ascoltare"), l'impegno ad operare
secondo la legge del Signore ("osservare"), ripetere alle nuove
generazioni l'atteggiamento concreto del crescere verso l'età
adulta (" insegnare"). Il testo, per richiamare la quotidianità
e la fedeltà alla Parola del Signore, elenca alcuni momenti di
vita che toccano gli estremi: "quando ti troverai in casa tua e
quando camminerai per la via, quando ti coricherai e quando ti
alzerai" (v 7). Solo così il popolo può vivere in pace e nel
benessere. Il brano, che leggiamo oggi, suppone tutto questo
impianto di esperienza, di quotidianità, di ubbidienza alla
Legge, e imposta gli elementi fondamentali di trasmissione della
sapienza al mondo giovanile che si prepara a diventare adulto.
La quotidianità comporta giudizi e scelte diverse. Perciò è
essenziale che esistano domande, che vengano formulati degli
interrogativi sulle motivazioni. La coerenza e la testimonianza
degli adulti, poi, vengono inevitabilmente a confronto con altre
esperienze ed altre le popolazioni di diverse culture: questo
semplice fatto ci interpella. Senza
interrogativi non c’è ricerca, intelligenza, maturazione,
sapienza. Per il mondo ebraico si colgono i significati e si
sviluppano scelte coerenti solo se si ha la preoccupazione della
ricerca di spiegazioni. Questo vale per la scuola, per la
famiglia, per la vita di ogni giorno. E se è facile che siano i
bambini di tenera età ad insistere sui perché, rendendo
proverbiale e curiosa la loro ostinazione, nella nostra cultura
e nella nostra sensibilità, soprattutto, in questo nostro tempo,
di scienza e di ricerca, curiosamente, non accettiamo più di
interrogarci e tendiamo a misurare il senso delle cose e delle
proposte dalla propria istintività e simpatia. Stiamo
esasperando a dismisura le scelte e le accoglienze, solo
legandoci alla emotività del "mi piace" o "non
mi piace |
Efesini 5, 15-20
Fratelli, Fate dunque molta attenzione al vostro modo di
vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, 16facendo buon
uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò
sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del
Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo
di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra
voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al
Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per
ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.
Paolo sta suggerendo agli Efesini, nella seconda parte della
sua lettera (4,1-6,24), le conseguenze morali
dell'essere nella Chiesa (prima parte: 1,3-3,21), corpo di
Cristo. Bisogna cominciare da un serio esame
di coscienza, dice Paolo (v,15 ) per verificare se ci sono
rimaste nel cuore tracce di stile e di comportamenti precedenti
pagani. Il tempo va vissuto con intelligenza ("non da
insipienti") e con saggezza. "I tempi sono cattivi" perché
dominati dal male e dalla lontananza da Dio. L'analisi del tempo
e della storia, nella fede, deve aiutarci a scoprire la volontà
di Dio che non è facilmente decifrabile. C'è il rischio, per noi
come per tutti, di essere "sconsiderati", incapaci
di interpretare il tempo. C'è infatti il rischio di
ricadere in forme di ebbrezza che nascono dal vino e che si
sviluppano nello stordimento e nella istintività sessuale
degradante. Tanto più che queste forme di esaltazione sono
caratteristiche anche come elementi e manifestazioni religiose
di stordimento, pensa Paolo, legate alla iniziazione del culto
di Dioniso, che porta a convulsioni, a condotte di invasati, a
sregolatezza. Come cristiani ci inebriamo solo dello Spirito di
Dio, capace di mantenere nella sobrietà e nel rispetto della sua
volontà. Le manifestazione dei battezzati si sviluppano così nel
canto, nella preghiera, nel ringraziamento. Facilmente oggi si
parla di sballo, di brivido, di rischio, di esaltazione e si
lega il tutto al gioco d’azzardo, alla droga anche se persiste,
pure tra giovanissimi, il mai finito rischio dell'alcool. Paolo
crede veramente al valore dei cristiani nella società che
portano una presenza coraggiosa ed esemplare
poiché questa, come il sale, come la luce, crea imitazioni e
equilibri nuovi, sanità mentale e santità. Sappiamo di essere in
tempi di difficoltà e di crisi e nella storia questi tempi,
spesso, alimentano suggestioni per una ricchezza gratuita,
offerta dalla fortuna, dal caso, dal rischio, dalle macchinette
mangiasoldi. Proprio in questi periodi si stanno moltiplicando
le abitudini a bische, a scommesse sempre più pesanti per
tentare la fortuna, e si entra,così, come in un tunnel,
asserviti ad una droga, irresistibile fino al punto da far
cercare danaro in prestito. Si asciuga in brevissimo tempo il
reddito mensile di lavoro, si mette sul lastrico la propria
famiglia. Nella nostra società, facilmente, si approfitta di
questa debolezza e si incentiva, anche con
metodi molto semplici ma persuasivi, la volontà di giocare e di
vincere denaro. Il pericolo si fa sempre più costringente ed è
difficile uscirne. Questo fenomeno è conosciuto molto bene dai
gruppi della Caritas delle parrocchie che si occupano di
attenzione ai poveri .
|
Giovanni 11, 1-53In quel tempo. Un
certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era
malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i
piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono
dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu
ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio
venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai
discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli
dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di
nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina
di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di
notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse
loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado a svegliarlo».
Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà».
Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del
riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono
contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da
lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo
anche noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da
quattro giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di tre
chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria
  Il
“settimo segno”, del Vangelo di Giovanni, molto complesso per la nostra
comprensione, va letto nella sua prospettiva teologica, così come Giovanni cerca
di suggerire. È, infatti, un brano carico di elementi inspiegabili, se lo
vogliamo interpretare semplicemente come un ritorno alla vita di prima di
Lazzaro, al prima della malattia e della morte. Qui si vuole restituire il
significato della presenza di Gesù che è vita e che, proprio nel presente, se
noi crediamo, è capace di far superare la morte per ricondurci nella pienezza di
Dio. Seguendo passo passo il testo, ritroviamo l’annuncio della malattia di
Lazzaro che è un amico, e insieme scopriamo una strana indifferenza di Gesù che
non si muove e costruisce strani discorsi, richiamando la morte come gloria di
Dio e come avvenimento per la fede dei discepoli. Poi Gesù ritorna a Betania e
non va a cercare Marta e Maria nella loro casa. Quella casa è il luogo della
disperazione e della morte, il luogo delle condoglianze e della realtà in cui
non c’è Il
“settimo segno”, del Vangelo di Giovanni, molto complesso per la nostra
comprensione, va letto nella sua prospettiva teologica, così come Giovanni cerca
di suggerire. È, infatti, un brano carico di elementi inspiegabili, se lo
vogliamo interpretare semplicemente come un ritorno alla vita di prima di
Lazzaro, al prima della malattia e della morte. Qui si vuole restituire il
significato della presenza di Gesù che è vita e che, proprio nel presente, se
noi crediamo, è capace di far superare la morte per ricondurci nella pienezza di
Dio. Seguendo passo passo il testo, ritroviamo l’annuncio della malattia di
Lazzaro che è un amico, e insieme scopriamo una strana indifferenza di Gesù che
non si muove e costruisce strani discorsi, richiamando la morte come gloria di
Dio e come avvenimento per la fede dei discepoli. Poi Gesù ritorna a Betania e
non va a cercare Marta e Maria nella loro casa. Quella casa è il luogo della
disperazione e della morte, il luogo delle condoglianze e della realtà in cui
non c’è più speranza. Perciò Gesù aspetta fuori sia Marta che
Maria. Ma quando le due sorelle lo incontrano, il primo saluto è un rimprovero.
“Perché non sei venuto prima, perché hai accettato che morisse?” E’ il dramma di
ciascuno di noi di fronte alla morte, è la sintesi degli interrogativi quando
non ci sentiamo ascoltati nelle nostre preghiere. “Dov’è Dio? Perché non sei
presente se sei così grande?” Gesù riporta al senso della vita: siamo immagine
di Dio ma questa vita non è tutto. E’ solo un tempo transitorio. Certamente è un
tempo in cui si costruisce una comunità e una speranza, è tempo di fedeltà, di
incontro, di amicizia. In questa vita si intrecciano rapporti stretti e
profondi, ma, con la morte, si scompare ai rapporti normali e carichi di
affetto, alle collaborazioni, alla reciproca condivisione. E
di questo anche Gesù soffre; per questo Gesù piange, ma non come gli altri. Il
suo non è un pianto disperato, ma un pianto di nostalgie e di amicizia per una
temporanea lontananza (i verbi greci del testo chiariscono la differenza tra il
pianto di Gesù e quello delle sorelle). Allora Gesù, fremendo, si reca al
sepolcro – è una grotta – “ e contro di essa è posta una
pietra”. Ci sono tre verbi imperativi che Gesù pronuncia ai suoi: “togliere”,
“sciogliere” e “lasciare”. “Togliete la pietra”: la pietra impedisce la
comunicazione tra i morti e i vivi. “E gli rispose Marta, la sorella del morto”.
Marta è ricordata come la sorella del morto e non di Lazzaro: l’idea della morte
domina questa comunità. “«Signore, manda già cattivo odore»”. Al terzo giorno la
morte si considera definitiva: inizia ormai irreversibile la decomposizione del
cadavere. Gesù dice: “Se credi, vedrai la gloria di Dio”. Così, alla tomba, Gesù
grida con forza la fede nella vita piena. Il morto esce dal luogo della
desolazione con i segni della morte.“Scioglietelo e lasciatelo andare”. Alle
persone vicine Gesù chiede di liberare Lazzaro dai legami della morte e solo ora
è pronto per andare al Padre (come Gesù andrà al Padre).Gesù non restituisce
Lazzaro alla comunità ma questa comunità deve rivedere il nuovo cammino di
gloria di Lazzaro:“Bisogna lasciarlo andare”. Bisogna credere che è con il Padre
nella pienezza della vita poiché crede in Gesù e non è più legato nel sepolcro.
Questo lasciarlo andare vale anche per noi che, spesso, cerchiamo di trattenere
il defunto con le visite ossessive al cimitero, con l’attaccamento morboso ai
suoi effetti personali, con il ricorso ai medium… È doloroso essere lasciati dai
genitori, fratelli, sorelle, figli, parenti, amici. Ma abbiamo fiducia sapere
che chi abbiamo amato, ed abbiamo perso ai nostri occhi, è entrato nel mondo del
Figlio e che perciò ci resta vicino. E’ come accettare di vederlo rinascere ad
un mondo splendido che noi non conosciamo, se non per sentito dire da parte di
Gesù, un mondo nuovo perché fatto dal Padre. Il segno di Betania ha rimesso in
moto paure, recriminazioni, progetti di morte tra i personaggi dell’autorità
religiosa di Gerusalemme. Gesù è capace di garantire la vita davanti alla morte,
ma sa che deve accettare di passare anche lui nella morte per essere, in
pienezza, per tutti, vita e quindi il primogenito dei risorti.
Negli ultimi versetti del testo vengono sintetizzati tutti i retroscena di ciò
che sarebbe stata poi la conclusione della vicenda di Gesù. Ma al sommo dello
stupore che la comunità cristiana maturerà via via, il significato teologico
della morte di Gesù viene proprio pronunciato dal nemico acerrimo: Caifa, sommo
sacerdote di quell’anno. Egli afferma: “Non vi rendete conto che è conveniente
per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione
intera!». Dio è capace di trasformare anche i tragici progetti
di morte in opere grandiose di vita per cui Gesù muore “per riunire insieme i
figli di Dio che erano dispersi” (v 52). |
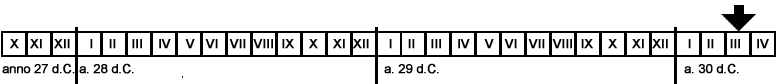

 Il
“settimo segno”, del Vangelo di Giovanni, molto complesso per la nostra
comprensione, va letto nella sua prospettiva teologica, così come Giovanni cerca
di suggerire. È, infatti, un brano carico di elementi inspiegabili, se lo
vogliamo interpretare semplicemente come un ritorno alla vita di prima di
Lazzaro, al prima della malattia e della morte. Qui si vuole restituire il
significato della presenza di Gesù che è vita e che, proprio nel presente, se
noi crediamo, è capace di far superare la morte per ricondurci nella pienezza di
Dio. Seguendo passo passo il testo, ritroviamo l’annuncio della malattia di
Lazzaro che è un amico, e insieme scopriamo una strana indifferenza di Gesù che
non si muove e costruisce strani discorsi, richiamando la morte come gloria di
Dio e come avvenimento per la fede dei discepoli. Poi Gesù ritorna a Betania e
non va a cercare Marta e Maria nella loro casa. Quella casa è il luogo della
disperazione e della morte, il luogo delle condoglianze e della realtà in cui
non c’è
Il
“settimo segno”, del Vangelo di Giovanni, molto complesso per la nostra
comprensione, va letto nella sua prospettiva teologica, così come Giovanni cerca
di suggerire. È, infatti, un brano carico di elementi inspiegabili, se lo
vogliamo interpretare semplicemente come un ritorno alla vita di prima di
Lazzaro, al prima della malattia e della morte. Qui si vuole restituire il
significato della presenza di Gesù che è vita e che, proprio nel presente, se
noi crediamo, è capace di far superare la morte per ricondurci nella pienezza di
Dio. Seguendo passo passo il testo, ritroviamo l’annuncio della malattia di
Lazzaro che è un amico, e insieme scopriamo una strana indifferenza di Gesù che
non si muove e costruisce strani discorsi, richiamando la morte come gloria di
Dio e come avvenimento per la fede dei discepoli. Poi Gesù ritorna a Betania e
non va a cercare Marta e Maria nella loro casa. Quella casa è il luogo della
disperazione e della morte, il luogo delle condoglianze e della realtà in cui
non c’è