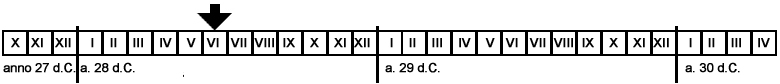
DOMENICA DELLA SAMARITANA
II di Quaresima
29 febbraio 2018
Giovanni
4, 5-42
Riferimenti : Deuteronomio 5, 1-2. 6-21 - Salmo 18 -
Efesini 4, 1-7 |
| La legge del Signore è perfetta, rinfranca
l’anima; il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;i giudizi del
Signore sono fedeli, sono tutti giusti. |
|
Deuteronomio 5, 1-2. 6-21
In quei
giorni. Mosè convocò tutto Israele e disse loro:
«Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi
io proclamo ai vostri orecchi: imparatele e
custoditele per metterle in pratica. Il Signore,
nostro Dio, ha stabilito con noi un’alleanza
sull’Oreb. “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti
ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla
condizione servile. / Non avrai altri dèi di
fronte a me. / Non ti farai idolo né immagine
alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto
è quaggiù sulla terra né di quanto è nelle acque
sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro
e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo
Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa
dei padri nei figli fino alla terza e alla
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma
che dimostra la sua bontà fino a mille
generazioni, per quelli che mi amano e osservano
i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il
nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non
lascia impunito chi pronuncia il suo nome
invano. Osserva il giorno del sabato per
santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha
comandato. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo
lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in
onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun
lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né
il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo
bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il
forestiero che dimora presso di te, perché il
tuo schiavo e la tua schiava si riposino come
te. Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra
d’Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto
uscire di là con mano potente e braccio teso;
perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di
osservare il giorno del sabato. Onora tuo padre
e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha
comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e
tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio,
ti dà. / Non ucciderai. / Non commetterai
adulterio. / Non ruberai. / Non pronuncerai
testimonianza menzognera contro il tuo prossimo.
Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non
bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo
campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né
il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che
appartenga al tuo prossimo”».
Nel libro del Deuteronomio (5,1-2.6-21),
Mosè inizia il suo secondo discorso in cui
svilupperà l'esortazione all'osservanza della
legge di Dio nell'Alleanza del Sinai (cc 6-11).
E, prima di tutto, ricorda i precetti del
Signore che vogliono esprimere le esigenze che
il popolo deve concretamente sviluppare per
entrare in comunione con Dio. Vengono detti
"Decalogo": sono, infatti, le "dieci parole" che
Dio pronuncia per ricostruire un popolo libero e
duraturo, a somiglianza delle dieci parole che
l'autore biblico ricorda nel primo racconto
della creazione per creare il mondo (Gen. 1). Se
Dio può fare il mondo gratuitamente e da solo,
può però mantenere nella consistenza e nella
vitalità il suo popolo solo mediante
l'ubbidienza alle sue leggi.
Questa edizione
dei "Comandamenti" è simile ad un'altra,
presentata nel libro dell'Esodo (20,2-17). Tutte
e due, in sintesi, ripercorrono i fondamentali
doveri religiosi e morali dell'uomo verso Dio e
il prossimo. Qualche variazione, nel libro del
Deuteronomio (che leggiamo oggi) è data dalla
preoccupazione di rendere più attuale e viva la
Parola di Dio. Nella tradizione occidentale, la
proibizione dell'immagine è parte del primo
comandamento mentre sono due i comandamenti del
"desiderio": "non desiderare la donna d'altri e
la roba d'altri" (il 9° e il 10º). Nelle
comunità ebraiche, invece, la proibizione delle
immagini è un comandamento a sé, mentre i
comandamenti del "desiderio", il 9° e il 10º,
vengono formulati come un solo comando. Dopo il
precetto sul "nome" divino da non violare
"invano", cioè con un uso magico e offensivo,
appare la prima notevole variante. Essa è nel
comandamento sul sabato. Il riposo e il culto
del sabato, nel capitolo 20 dell'Esodo (vv.
8-11), erano considerati una celebrazione
dell'opera della creazione ( si rilegga Genesi
2,1-4). Ora, invece, il sabato è visto come
memoria della liberazione dalla schiavitù
d'Egitt0. E' quindi il giorno della libertà' per
cui ci si deve ricordare del Signore che vince
ogni oppressione e invita Israele a superare
ingiustizia e schiavitù. Infine, con l'ultimo
comandamento, che unisce il nono e il decimo
sotto l'imperativo del "non desiderare" (cioè
del non progettare il male), si ha la seconda
variazione di rilievo. La donna viene anticipata
rispetto alla casa, al campo, agli schiavi, agli
animali del prossimo: si tempera, così, la
visione arcaica maschilista che riduceva la
donna a un bene di proprietà della famiglia.
Gesù dirà che per entrare nella vita eterna sono
sufficienti i dieci comandamenti (Mc 10,17-22).
Poi però Gesù aggiungerà i consigli evangelici.
Al di fuori della Legge, l'Antico Testamento
ricorda raramente il decalogo, anche se ci sono
dei richiami (Os 4,1; Ger 7,8; Salmo 81,10-11)
ma acquisterà molto valore nel Cristianesimo
attraverso l'uso che se ne fa nel Nuovo
Testamento. "Colui che comanda è anche il tuo
liberatore" (v 6): sono leggi per la tua
salvezza, per la tua speranza, per la tua
libertà.
|
Efesini 4, 1-7
Fratelli, io,
prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni
umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito
per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo
spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che
è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente
in tutti. / A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo.
Inizia, nella lettera agli Efesini, una seconda parte che
intende suggerire un progetto di vita cristiana, ancorata
all'unità di credenti che costituiscono il corpo di Cristo.
Vengono dati cinque suggerimenti di comportamento, e il numero
cinque potrebbe essere il richiamo alla Legge, alla nuova Legge
come per gli ebrei la Legge è costituita nei primi cinque libri
della Scrittura. Comportarsi in maniera degna della chiamata
significa vivere "con umiltà, dolcezza, magnanimità,
sopportazione nell'amore ( e potrebbe essere tradotto come
accoglienza) e responsabilità dell'unità per mezzo della pace".
Paolo premette, a questo suggerimento di vita, il fatto di
essere "prigioniero a motivo del Signore". Egli si pone come
richiamo di stile di vita: infatti si è giocato la libertà e il
futuro, probabilmente, per la fede in Gesù. Egli crede in Gesù e
vuole intensamente che viva nel cuore di ogni comunità. Così,
ricordando il coraggio della unità, elenca sette ragioni perché
ci sia un cammino di comunione. Inizia dall'essere "un unico
corpo" fino ad avere "un unico Dio, padre di tutti".
L'esperienza rende consapevoli del lavoro che bisogna fare per
la fede, perché bisogna vivere in una comunità. E Paolo si
preoccupa di dire: "Avete, fondamentalmente, a modello Cristo
che accoglie tutti senza distinzione, si mette a disposizione di
tutti, offre la sua vita per tutti". L'unità nella comunità
cristiana non è frutto di simpatia, di interessi, di accordi, di
razza, lingua, cultura, mentalità, carattere. Persino la stessa
religione può portare a indurimenti e a tensioni diversi, fino a
giungere ad esclusioni, a lacerazioni, a rifiuti. Se poi ci si
gioca in una dimensione di potere, proprio la scusa del
difendere la religione può condurre all'oppressione dell'altro.
La storia della Chiesa si offre anche questi esempi. Tutto ciò
nasce dalla istintività, dalla radice di male che faticosamente
ciascuno deve estirpare da sé, da paure, dalla volontà di
potenza. Tutto il testo continua nell'incoraggiare una unità
matura, adulta, fedele, capace di accoglienza. Ciascuno è
chiamato ad una collaborazione, e deve svolgere una sua
vocazione ed un suo compito. La nostra esperienza, superando
diffidenze e paure, ci sta insegnando che le diversità
costituiscono ricchezza. Vanno favoriti gli incontri, gli aiuti
reciproci, la collaborazione. A ciascuno di noi sono stati dati
doni particolari. Mantenendo con coraggio l'unità e
l'accoglienza, questi doni si moltiplicano e diventano
testimonianza, capaci di portare speranza nel mondo. Tutto
questo è segno e premessa di pace.

Cittadina di Sichar ove vi è il pozzo di Giacobbe |
 Giovanni
4, 5-42 Giovanni
4, 5-42
In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi
discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui
che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe
dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo
è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi
figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più
sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente
d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –,
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui
ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli
risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non
ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo
marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le
dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa
– in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così
infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e
quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci
annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In quel
momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con
lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla
gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto.
Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i
discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da
mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un
l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il
mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua
opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”?
Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già
biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto
per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo
infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho
mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi
siete subentrati nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città
credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto
tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo
pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più
credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del mondo».
Giovanni
(4,5-42) racconta l'episodio della samaritana, richiamando il viaggio che fa
dalla Giudea alla Galilea (v 3): vuole sviluppare la conoscenza di Gesù,
ricordando la rivelazione fatta alla Samaritana, ai discepoli e, alla fine,
ai Samaritani chiamati dalla Samaritana stessa. Gesù, da poco tempo, ha
incominciato a predicare e a manifestare il suo messaggio. Incontra diverse
reazioni di fede (raccolte in questi primi capitoli di Giovanni): Nicodemo
(la fede imperfetta dei Giudei sempre bisognosi di segni per credere:
Gv.3,1-21), la samaritana (la fede pronta: Gv.4,5-42) e il funzionario reale
(adesione piena a Cristo: Gv.4,46-54). Gesù, veramente stanco del viaggio, è
preoccupato di raggiungere e di sostenere il mondo lontano dei samaritani,
disprezzati dai credenti e odiati. Nella cultura ebraica dire ad uno
"samaritano" era come dire "eretico, pagano, miscredente, rifiuto di Dio". E
per questo Gesù, per provocazione, ricorda i samaritani come protagonisti:
uno per tutti la Parabola del Buon Samaritano" I Samaritani discendevano da
un miscuglio di popolazioni importate dagli Assiri nel 721 a.C. per
ripopolare la Samaria distrutta. Essi avevano contaminato la religione di
Jahvè con credenze idolatriche e, perciò, dopo il ritorno da Babilonia (538
a.C.), i Giudei non vollero avere alcun rapporto con loro, ritenendoli impuri
come i pagani La rivalità aumentò quando il sommo sacerdote giudeo Giovanni
Ircano distrusse il loro tempio sul monte Garizim nel 128 a.C. Ritenevano
ispirati solo i 5 libri di Mosè (la legge). Il pozzo di Giacobbe è il più
profondo pozzo in Palestina (circa 30 metri). E proprio qui, nel richiamo di
Giacobbe, capostipite del popolo d'Israele, Gesù si fa mendicante di acqua: è
il suo modo discreto per iniziare un dialogo con una donna infedele e per
riconquistarla alla verità. Due sono i valori fondamentali: il dono
dell'acqua viva (simboleggia la rivelazione di Gesù) e il dono dello Spirito,
che garantisce il nuovo culto "in Spirito e verità". Vi è una introduzione
storico-geografica (vv 4-6) e una conclusione storico-teologica (vv 39-42).
Il racconto si svolge in due grandi scene: il dialogo di Gesù con la
Samaritana (vv 7-26) e quello con i discepoli (vv 31-38) che ritornano,
mentre la Samaritana va in città ad annunciare (vv 27-30). E il colloquio con
la Samaritana è diviso in due parti (vv 31-34 e 35-38). In tutto il testo si
sviluppa la conoscenza progressiva dì Gesù: un giudeo (v 9), uno più grande
di Giacobbe (v 12), un Signore capace di compiere un prodigio (v 15), un
profeta (v 19), il Messia che viene alla fine della storia (vv 25-26,29),
l'inviato del Padre che, a sua volta, invia (vv 34-38), il Salvatore del
mondo ( v 42). La domanda predominante: "Chi è colui che ti parla?" (v 10) ha
due risposte. Gesù è Messia (v 26) e Gesù è salvatore del mondo (v42),
proclamato solennemente. Varie riflessioni sì profilano: Gesù è acqua viva,
rivelazione e Spirito. Egli chiede la conversione del cuore, propone un culto
genuino, invia nel mondo per la salvezza di tutti, mentre la Samaritana è la
donna disincantata, lontana da Dio ma coraggiosa, attenta mentre devia i
tentativi di Gesù di farla riflettere su se stessa. Eppure non fugge davanti
a Gesù. Con tutte le sue perplessità, alla fine accetta di fare un cammino di
ricerca e fedeltà per arrivare alla verità: acqua viva.
|