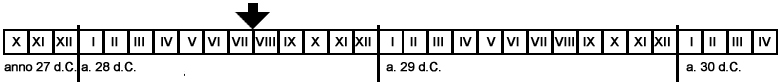
PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
4
febbraio 2018
Luca 7, 36-50
Riferimenti : Osea 6, 1-6 - Salm0 50 -
Gàlati 2, 19 – 3, 7 |
| Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua
grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla
mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu non gradisci il
sacrificio; se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito
contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o
Dio, non disprezzi. |
|
Osea 6, 1-6
Così dice il Signore
Dio: «Voi dite: “Venite, ritorniamo al Signore:
/ egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. /
Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. / Dopo
due giorni ci ridarà la vita / e il terzo ci
farà rialzare, / e noi vivremo alla sua
presenza. / Affrettiamoci a conoscere il
Signore, / la sua venuta è sicura come l’aurora.
Verrà a noi come la pioggia d’autunno, / come la
pioggia di primavera che feconda la terra”. /
Che dovrò fare per te, Èfraim, / che dovrò fare
per te, Giuda? / Il vostro amore è come una nube
del mattino, / come la rugiada che all’alba
svanisce. / Per questo li ho abbattuti per mezzo
dei profeti, / li ho uccisi con le parole della
mia bocca / e il mio giudizio sorge come la
luce: / poiché voglio l’amore e non il
sacrificio, / la conoscenza di Dio più degli
olocausti».
Osea, che vive nel
secolo ottavo a. C., è testimone di una tragedia
che ha coinvolto le tribù del Nord e le tribù
del Sud di Israele. Le tribù del Nord, chiamate
in questo caso Efraim, desiderose di scrollarsi
di dosso il giogo assiro, attaccano le tribù del
Sud, abitanti nella Giudea e quindi a
Gerusalemme, essendosi già impossessate di città
più piccole vicine. Esse immaginano di
contrastare così l'impero assiro.
Ma il re
Acaz, re di Giuda, nonostante l'invito
insistente di Isaia di non rivolgersi al re
straniero, chiede l'intervento della signoria
Assira che arriva velocemente e devasta con
brutalità, vandalismi e ferocia tutto il
territorio del Nord. In questo caso, però,
travolge anche il Sud di Israel, se non altro
facendo pesare l'intervento e il soccorso con
pesanti tributi. Di fronte a questa tragedia,
finalmente, ci si rende conto che ciò che è
avvenuto è causato dalla disobbedienza e dalla
infedeltà a Dio. Egli aveva mandato avvisi
precisi ma il re e il popolo non hanno voluto
ascoltare. A questo punto, però, finalmente, ci
si rivolge a Dio dopo la sconfitta, convinti che
una conversione rimetterà a posto le cose: di
Dio ci si può fidare. "Egli guarisce, Egli
fascia le piaghe, Egli ridà la vita in breve
tempo (tre giorni)". La sua presenza e il suo
intervento sono garantiti come l'aurora, come la
pioggia d'autunno e di primavera: il sole
illumina e la pioggia feconda la terra. Questa è
la fede che il popolo d'Israele riesce a
recuperare nei momenti di difficoltà e di crisi.
Ma il Signore risponde attraverso il profeta e
usa le stesse immagini ma riducendole: nube nel
mattino, e quindi nube che oscura i sole, e
rugiada, solo rugiada che svanisce ai primi
raggi. Il Signore rimprovera la fragilità e la
superficialità del rapporto che il suo popolo ha
con Lui. E infatti tutta la religiosità di
Israele, che di fronte alla sventura moltiplica
i sacrifici di animali e le offerte al tempio,
deve rivedere la propria posizione, maturando
l'amore e la misericordia, la conoscenza di Dio
prima degli olocausti e dei sacrifici. L'ultima
frase: "Voglio l'amore, non sacrificio, la
conoscenza di Dio più degli olocausti" (v 6) è
sempre molto presente nell'opera di Gesù,
soprattutto nei momenti difficili in cui egli
affronta situazioni di discriminazione, di
rifiuto delle persone, di giudizi, di
opposizione violenta verso coloro che sbagliano.
E di fatto Gesù utilizzerà questa frase proprio
come risposta allo stupore di scandalo e di
recriminazione verso di Lui da parte di cultori
della legge, esigenti e fedeli (i farisei). Gesù
accetta di mangiare insieme con pubblicani e
peccatori, amici di Matteo che Gesù stesso aveva
invitato a seguirlo come discepolo (Matteo
9,9-13). E questo crea una opposizione
durissima. Gesù conclude: "Non sono venuto a
chiamare i giusti ma i peccatori. Non sono i
sani che hanno bisogno del medico ma i malati.
Andate dunque e imparate che cosa significhi
misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti
non sono venuto a chiamare i giusti ma i
peccatori".
|
Gàlati 2, 19 – 3, 7
Fratelli,
mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per
Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me. Dunque non rendo vana la grazia di Dio; infatti,
se la giustificazione viene dalla Legge, Cristo è morto invano.
O stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi
dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso!
Questo solo vorrei sapere da voi: è per le opere della Legge che
avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della
fede? Siete così privi d’intelligenza che, dopo aver cominciato
nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della
carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano!
Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo
a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o perché avete
ascoltato la parola della fede? Come Abramo ebbe fede in Dio e
gli fu accreditato come giustizia, riconoscete dunque che figli
di Abramo sono quelli che vengono dalla fede.
Paolo si sente particolarmente perseguitato da
gruppi di ebrei convertiti che però temono di abbandonare le
usanze e la mentalità ebraica. Sono quelli che vengono "da parte
di Giacomo"(2,12) (responsabile della Chiesa di Gerusalemme).
Pietro stesso ha seguito una condotta di comunione con i pagani
convertiti e mangia serenamente con loro senza problemi, ad
Antiochia. Ma il fatto di questa venuta ha irrigidito i rapporti
per cui "Pietro cerca di tirarsi indietro e di appartarsi,
timoroso dei giudei convertiti. Presero il suo atteggiamento
falso anche altri giudei e perfino Barnaba" (v13). Il problema
che sorge è squisitamente teologico. Chi o che cosa salva? Sono
le regole, la legge, le remore che bisogna rispettare e che,
nella condizione in cui ci troviamo, ci fanno sentire travolti
da separazioni e diffidenze, rifiuti e lacerazioni? O ci salva
la fede in Gesù che ci garantisce una fraternità, il superamento
dell'esclusione, la scoperta di un amore universale che ci apre
ad essere il nuovo popolo? Si riesce allora a capire la reazione
di Paolo: "Egli si oppose a Pietro, affrontandolo direttamente a
viso aperto" (v 11). Paolo infatti vuole riproporre nelle sue
lettere e nella sua predicazione la fede in Gesù come struttura
fondamentale. Si capisce allora tutta la sua insistenza e la sua
polemica nella contrapposizione tra fede e opere. C'è il
pericolo, sempre presente, di pensare che tutto dipenda da noi,
dalle nostre azioni, dei nostri criteri di comportamento, e non
dalla forza della fede e dalla ricerca di Gesù. Il Paradiso ci
viene dato dalla grazia di Dio perché egli ci considera suoi
figli e vuole che, insieme con lui, possiamo godere la bellezza
e la grandezza della Sua vita. Questo atteggiamento ci porta ad
essere attenti, rispettosi della sua Parola e fondamentalmente
riconoscenti e gioiosi del dono che Gesù ci ha fatto. Certamente
tutto questo ci porta a vivere secondo la sua Parola, ma la
religione cristiana è ringraziamento, insieme con la
responsabilità, e diventa dono insieme con l'impegno e diventa
comunione con gli altri perché figli dello stesso Padre. Paolo
si mostra durissimo con i suoi fratelli Galati che egli ha
convertito. Chiamandoli per ben due volte, persone "senza
criterio" (o stolti), elenca cinque domande la cui risposta è
una sola, quella, cioè, che Paolo stesso desidera far loro
capire: "Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti
in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o perché
avete ascoltato la parola della fede?" L'immagine che Paolo
continua a proporre è quella di Abramo "che ebbe fede in Dio e
gli fu accreditato come giustizia".
|
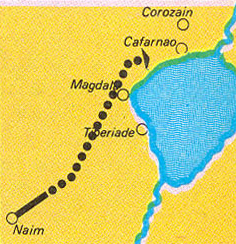 Luca 7, 36-50 Luca 7, 36-50
In quel tempo. Uno dei farisei invitò il
Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a
tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si
trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro,
presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo
questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un
profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli
rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli
doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di
più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli
disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a
Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da
quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con
olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io
ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece
colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati
sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è
costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede
ti ha salvata; va’ in pace!». Dio è in visita del suo
popolo attraverso l'attività di Gesù. In questo capitolo 7 guarisce il servo
di un centurione, risuscita un fanciullo morto di Nain, risponde alla domanda
di Giovanni Battista e lo elogia, perdona la peccatrice. Quest'ultimo
episodio avviene durante un banchetto, di sabato, con Gesù invitato da
Simone, che è un fariseo onesto, e che vuole approfittare, all'uscita dalla
sinagoga, di parlare con Gesù, e continuare una riflessione sui testi biblici
di quel giorno, proposti e commentati, probabilmente, da Gesù stesso. E
desidera, nello stesso tempo, farsi un'idea più precisa di Gesù. Quasi
certamente si è preoccupato di avere, come commensali, altre persone di
corretta moralità per evitare che un pranzo non fosse rovinato da persone
impure o anche semplicemente rozze. Di giorno la porta della casa resta
sempre aperta, ma difficilmente qualcuno, malvisto, che non sia in confidenza
con colui che ospita si arrischia di entrare. Così, con stupore, si scopre
che si fa avanti una donna chiacchierata, e di dubbia fama. Non chiede
permesso a nessuno, punta dritto verso Gesù, si inginocchia piangente e
asciuga con i capelli sciolti i piedi di Gesù, bagnati dalle sue lacrime.
Tutti sono sconcertati e perplessi, ma nessuno la ferma o la scaccia, poiché
il capo di casa non fa nessun cenno. Egli resta a guardare. Però il suo volto
esprime perplessità e irritazione, ma anche curiosità circa il comportamento
di Gesù. Gesù, allora, inventa, lì per lì, una parabola di misericordia e
quindi Lui stesso si preoccupa di applicarla alla situazione creatasi.: "Vedi
questa donna?". Chi ama di più? E risponde: colui o colei a cui è stato
perdonato di più. E Gesù fa emergere i gesti di maggiore amore:
l'accoglienza, le lacrime di pentimento, mentre il fariseo ospitante non ha
fatto nulla di tutto questo. Per sé non è tenuto ma è rimasto al limitare
della correttezza. Probabilmente questa donna ha già conosciuto Gesù, ed ha
già ricevuto una consolazione per la sua speranza. Per questo ama di più, e
compie gesti coraggiosi e umili, gesti di chi si sente aiutata e perdonata.
Ama di più perché sa scoprire la sua povertà e sa apprezzare la grandezza di
amore e di gioia a cui Gesù si richiama. Il fariseo, invece, ritiene di non
aver bisogno di perdono. Non è disonesto ma è un estraneo a Gesù e da Lui si
aspetta molto poco.
|
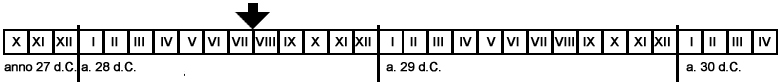
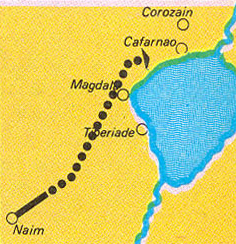 Luca 7, 36-50
Luca 7, 36-50