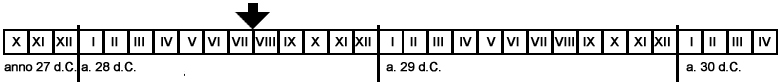
Penultima domenica dopo l'Epifania
Della divina clemenza
7 febbraio 2021
Lc 7, 36-50
Riferimenti : Os 6, 1-6 -Sal 50 - Gal 2, 19 – 3, 7 |
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.m, Pietà
di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio
peccato rendimi puro. |
|
Os 6, 1-6
Così dice il Signore
Dio: «Voi dite: “Venite, ritorniamo al Signore:
egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci
ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni
ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare, e
noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a
conoscere il Signore, la sua venuta è sicura
come l’aurora. Verrà a noi come la pioggia
d’autunno, come la pioggia di primavera che
feconda la terra”. Che dovrò fare per te,
Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro
amore è come una nube del mattino, come la
rugiada che all’alba svanisce. Per questo li ho
abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi
con le parole della mia bocca e il mio giudizio
sorge come la luce: poiché voglio l’amore e non
il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli
olocausti».
Osea 6, 1-6.
Il
Regno del Nord (o regno d'Israele chiamato anche
Efraim), costituito dalle 10 tribù ebraiche che
si erano separate dal Sud (regno di Giuda) al
tempo della morte di re Salomone (attorno al 930
a.C.), volle attaccare il regno del Sud nel 734
a.C. con l'aiuto della Siria. Così iniziò una
guerra di conquista per impossessarsi di alcune
città di Giuda, nella prospettiva di abbattere
pure Gerusalemme. Acaz, re di Giuda, nonostante
l'invito insistente di Isaia perché non si
rivolgesse ad un re straniero, chiese
l'intervento della Assiria che già dominava la
zona. L'esercito assiro arrivò velocemente e
devastò con brutalità, vandalismi e ferocia
tutto il territorio del Nord. Samaria, la
capitale del Nord, fu conquistata dal re Assiro
nel 721 a.C.
E se, rispetto alle minacce del
Nord, l'intervento dell'Assiria portò sollievo
momentaneo al Sud, tanto da incoraggiare
l'esercito di Gerusalemme a conquistare città
non proprie, tuttavia la situazione complessiva
si fece dura per tutti. Il popolo di Dio, tanto
a Nord che a Sud, non si era reso conto che
stava tradendo la fiducia in Dio, cercando
salvezza presso popoli pagani. Il profeta aveva
richiamato la fedeltà al Signore, ma la paura
non aveva fatto pensare che si dovesse riporre
la propria speranza in Dio. Nel frattempo anche
a Sud, a Gerusalemme, l'esercito dell'Assiria
impose tributi eccessivi e angoscianti. Perciò
il popolo, nel momento della fatica, si impose
sacrifici, ma capì che doveva tornare al
Signore. Perché accettasse le proprie offerte.
Si moltiplicarono le pratiche religiose, i
sacrifici di animali nel tempio, i doni votivi.
Sembrava un ritorno alla conversione sincera e
gli stessi fedeli s'immaginavano sinceri.
"Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha
straziato ed egli ci guarirà"(v 1).
Ma qui il
profeta, con un intervento indispensabile,
diventa la voce sonora e chiarificatrice del
pensiero di Dio. "Il Signore non sa che farsene
dei doni e dei gesti di culto che non
significano e non portano alla conversione.
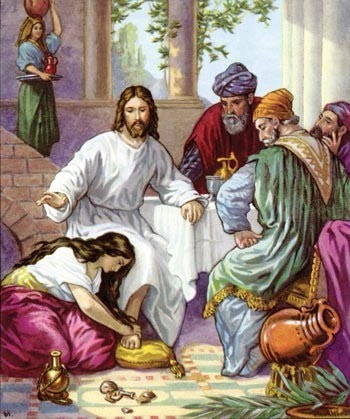 |
Gal 2, 19 – 3, 7
Fratelli,
mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per
Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me. Dunque non rendo vana la grazia di Dio; infatti,
se la giustificazione viene dalla Legge, Cristo è morto invano.
O stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi
dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso!
Questo solo vorrei sapere da voi: è per le opere della Legge che
avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della
fede? Siete così privi d’intelligenza che, dopo aver cominciato
nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della
carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano!
Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo
a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o perché avete
ascoltato la parola della fede? Come Abramo ebbe fede in Dio e
gli fu accreditato come giustizia, riconoscete dunque che figli
di Abramo sono quelli che vengono dalla fede.
Galati 2,19 - 3,7
Alcuni farisei convertiti, poiché avevano
accettato Gesù come Messia, contemporanei a Paolo, continuavano,
nella loro mentalità, a ritenere che il premio di Dio fosse
destinato a coloro che si erano preoccupati di accumulare molti
meriti mediante le opere buone. Perciò, secondo le loro
consuetudini, continuavano ad essere scrupolosissimi
nell'osservanza della legge e, nelle nuove comunità, riuscivano
ad immettere la stessa mentalità, provocando, tuttavia,
divisioni tra convertiti ebrei e convertiti dal paganesimo.
Uno scontro animato di Paolo con Pietro, e raccontato in questa
stessa lettera qualche versetto più sopra (2,11 ss), ricorda che
fu obbligatoria una chiarificazione tra loro, poiché anche
Pietro fu influenzato da questi nuovi venuti. Prima che
arrivassero nella comunità in cui viveva anche Paolo, Pietro si
comportava allo stesso modo, in armonia con tutti, sia ebrei che
pagani convertiti, frequentandosi senza problemi. Ma poi la
venuta di questi nuovi cristiani che disdegnavano i pagani, se
pur convertiti, con grandi pretese di cautele per l'impurità nei
confronti dei pagani stessi, secondo la legge, mise in crisi il
comportamento di molti compreso l'atteggiamento di Pietro che
"cominciò a evitarli ed a metterli da parte (pagani convertiti)
per timore dei circoncisi" (2,13). Questi "circoncisi" sono
quelli che vengono "da parte di Giacomo"(2,12) (apostolo
responsabile della Chiesa di Gerusalemme che aveva mantenuto una
mentalità più legata all'ebraismo).
Il problema che sorse era
squisitamente teologico. Chi o che cosa salva? Sono le regole,
la legge, le remore che bisogna rispettare e che, nella
condizione in cui ci troviamo, ci fanno sentire travolti da
separazioni e diffidenze, rifiuti e lacerazioni? O ci salva la
fede in Gesù che ci garantisce la fraternità, il superamento
dell'esclusione, la scoperta di un amore universale che ci apre
ad essere il nuovo popolo?
|
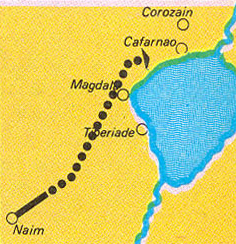 Lc 7, 36-50
Lc 7, 36-50
In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed
ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella
casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di
lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi
capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo
che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi
è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora
gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure,
maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il
debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose:
«Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai
giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa
donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non
ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei
invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale
si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati».
Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona
anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’
in pace!».
Luca 7,36-50
L'episodio, raccontato da Luca,
che va letto contestualizzandolo secondo le modalità dei banchetti ebraici di
quell'epoca, normalmente viene interpretato in termini di peccato e di
perdono così come lo presenta l'Evangelista. Ma, se guardiamo più a fondo, il
discorso è soprattutto tra Gesù e Simone il fariseo che lo aveva invitato.
Il giudizio del fariseo è perentorio e scandalizzato: "Non vede che è una
peccatrice?". E Gesù, dopo aver raccontato un breve eloquente apologo,
ribatte: "Vedi questa donna?" restituendo a lei un'integrità e una dignità,
depurata dal giudizio di Simone, il fariseo timorato di Dio.
E Gesù fa
notare, con grande dovizia di particolari, la sua grande capacità di amore:
un amore capace di gesti concreti, che nascono da una totale partecipazione
interiore e utilizzano elementi coinvolgenti, toccanti, come il bacio, i
capelli, il profumo. Fa venire in mente il Cantico dei Cantici.
Il peccato
viene dopo la capacità di amore della donna e consiste nell'aver deviato la
potenzialità. Però lei rimane la donna "che ha molto amato".
E Gesù la
rimette in cammino nella fede del suo perdono, ridonandole stima di fronte a
tutti coloro che azzardano giudizi secondo la convenienza e la superficialità
di chi si sente giusto, superiore di fronte agli altri e alle "altre". La tua
fede, cioè "il tuo amore ti ha salvato", cioè liberato dalla rete malevole
delle critiche sociali, perché coraggiosamente, pubblicamente, hai messo il
tuo amore e il tuo dolore nella fiducia in Gesù.
"Va in pace": rimettiti
in cammino nella pace, cioè nella consapevolezza che la tua capacità di amore
ha trovato la direzione di Gesù, perché ha toccato la sua comprensione ed è
stata toccata dal suo perdono, cioè da un amore che supera, comprende e
avvolge il suo. Come se dicesse: "Donna (non "peccatrice") continua ad amare
con tutta la tua passione, in piena dignità". E questa è la pace. |