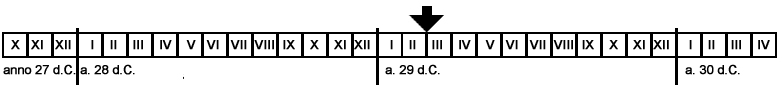
III Domenica dopo l'Epifania
24 gennaio 2021
Mt 14, 13b-21
Riferimenti : Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a - Sal 104 -
1Cor 10, 1-11b |
| Il Signore ricorda sempre la sua parola santa. È
lui il Signore, nostro Dio: su tutta la terra i suoi giudizi. Si
è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille
generazioni, dell’alleanza stabilita con Abramo e del suo
giuramento a Isacco. |
|
Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a
In quei giorni. La gente raccogliticcia, in
mezzo a loro, fu presa da grande bramosia, e
anche gli Israeliti ripresero a piangere e
dissero: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci
ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto
gratuitamente, dei cetrioli, dei cocomeri, dei
porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra
gola inaridisce; non c’è più nulla, i nostri
occhi non vedono altro che questa manna». La
manna era come il seme di coriandolo e aveva
l’aspetto della resina odorosa. Il Signore disse
a Mosè: «Dirai al popolo: “Santificatevi per
domani e mangerete carne, perché avete pianto
agli orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà
da mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto!
Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne
mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non
per due giorni, non per cinque giorni, non per
dieci giorni, non per venti giorni, ma per un
mese intero, finché vi esca dalle narici e vi
venga a nausea, perché avete respinto il Signore
che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a
lui, dicendo: Perché siamo usciti
dall’Egitto?”». Un vento si alzò per volere del
Signore e portò quaglie dal mare e le fece
cadere sull’accampamento, per la lunghezza di
circa una giornata di cammino da un lato e una
giornata di cammino dall’altro, intorno
all’accampamento, e a un’altezza di circa due
cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si
alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e
tutto il giorno dopo raccolse le quaglie.
Numeri. 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a
In marcia
verso il deserto di Paran, il popolo incomincia
a lamentarsi e si pone quindi i molti
interrogativi che sorgono all'interno di una
vita carica di imprevisti e costretta a
inventarsi, giorno per giorno, elementi di
sopravvivenza per poter resistere. I primi tre
versetti (11,1-tre) sintetizzano proprio "questo
lamentarsi aspramente" con un incendio che sorge
nell'accampamento, facile come sempre negli
accampamenti, di fronte a cui Mosé, pregando,
diventa il mediatore che fa spegnere il fuoco.
In concreto, la protesta del popolo sorge perché
non ha cibo sufficiente nel deserto. Come
risultato, il popolo è saziato con le quaglie
(vv. 4-9.10.13.18-24a) ma è pure castigato per
la sua ingordigia (vv. 31-33). Intrecciata col
racconto relativo alla bramosia di cibo, si ha
una storia riguardante la condivisione
dell'autorità di Mosè che qui non viene
riportata (vv. 11-12.14-17.24b-30). Due gruppi
distinti di persone, "la gente raccogliticcia e
gli israeliti" protestano per la scarsità di
cibo (v. 4) e rimpiangono i giorni in cui, in
Egitto, godevano abbondanza di pesce e verdure
(v. 5). Ora sono insoddisfatti perché tutto ciò
che hanno da mangiare è la manna, con la quale
fanno quotidianamente focacce che hanno il
sapore di pasta all'olio (vv. 6-9; cf. Es
16,13-14.31). Lo «sdegno del Signore divampò»
contro gli israeliti (v. 10). Ma lo stesso Mosè,
come il Signore, risponderanno ciascuno alla
protesta a modo loro e Mosè dimentica il suo
ruolo di mediatore. Infatti, contrariamente a
quello che ha fatto allo scoppio dell'incendio
(11, 2), Mosè stesso non intercede, ma si
lamenta di dover provvedere da solo a quella
grande moltitudine, e diffida della stessa
potenza di Dio perché Dio stesso non è capace di
provvedere per 600.000 persone e tanto più lo
stesso Mosè: «Da dove prenderò la carne da dare
a tutto questo popolo? Perché si lamenta contro
di me» (v. 13). Mosè ritiene di avere la
responsabilità di trovare carne, ma esprime la
propria impossibilità. Così, invece di cercare
l'aiuto di Dio, manifesta risentimento per la
posizione in cui è stato posto. "Perché hai
fatto del male al tuo servo? L'ho forse
concepito io tutto questo popolo? Se mi devi
trattare così, fammi morire piuttosto"
(11,11-15)
|
1Cor 10, 1-11b
Non
voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri
furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti
furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare,
tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la
stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia
spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo.
Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono
sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché
non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. Non
diventate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta
scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per
divertirsi. Non abbandoniamoci all’impurità, come si
abbandonarono alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero
ventitremila. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo misero
alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non
mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime
dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come
esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento.
Prima lettera ai Corinzi. 10, 1-11b
Dopo aver proposto alla
comunità dei cristiani di Corinto il proprio comportamento come
esempio di responsabilità, (cap. 9) e aver ricordato l'impegno
per la gratuità nel proprio incarico pastorale, utilizzando
anche immagini sportive, molto popolari a quel tempo, in
particolare a Corinto, con i giochi istmici a scadenza biennale,
Paolo incoraggia la comunità, pur generosa, di Corinto a vivere
con fedeltà la scelta di Gesù. Tuttavia l'apostolo si sofferma
su alcuni aspetti negativi: dissensi, invidie, immoralità,
esistenti, come ovunque, d'altra parte. Si corre il rischio di
immaginare, dice Paolo, che il proprio battesimo garantisca la
salvezza e che quindi sia sufficiente. Paolo si preoccupa
allora, utilizzando la sua competenza di rabbino, di richiamare
alcuni elementi fondamentali della fede ebraica, sviluppando
l'esegesi della liberazione dall'Egitto del popolo d'Israele in
rapporto a Mosé e quindi a Cristo. Gli israeliti hanno seguito
Mosé e si sono fidati di lui; hanno camminato sotto la nube,
hanno attraversato il mar Rosso, hanno mangiato la manna, hanno
bevuto l'acqua scaturita dalla roccia (una leggenda dice che la
roccia seguiva l'accampamento ovunque si posasse). "Ma la
maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono
sterminati nel deserto" (10,5). Così quell'evento diventa
esemplare anche per i cristiani: il passaggio del Mar Rosso è
immagine del battesimo, battesimo nel rapporto con Mosè. mentre
i cristiani sono in rapporto a Cristo. La manna e l'acqua sono
segni profetici dell'Eucaristia. E tuttavia non sono
sufficienti: né la fede in Cristo, né l'essere battezzati, né
aver ricevuto lo Spirito, né essersi cibati dell'Eucaristia per
ricevere automaticamente la salvezza. È necessario che si
sviluppino, insieme, una vita coerente di fede e quindi una vita
operosa secondo i criteri che Gesù ha portato, a cui, come
credenti in Gesù, sono stati iniziati nel battesimo e verso cui
siamo continuamente incoraggiati a camminare attraverso lo
Spirito. Se non esistono questa disponibilità, questa fiducia e
questo cammino, anche noi siamo a rischio di perderci come i
padri nel deserto.

|
 Mt 14, 13b-21
Mt 14, 13b-21
In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là
su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle,
avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli
vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi
stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver
ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono
via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano
circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
Matteo14, 13b-21
E' un testo molto complesso e molto costruito. Qui
l'evangelista vuole insegnare alcuni valori cristiani, richiamando dei segni
anche se, al momento, possono sembrare inverosimili. Con 5000 uomini c'è il
richiamo alla legione, come esercito, e qui si sentono i sogni e le esigenze
di un Regno che si deve costituire, mentre l'esercito è garanzia di un re che
deve venire ( Giovanni ne parla espressamente: "Gesù, sapendo che venivano a
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo": Gv 6,15).
Gesù non vuole un esercito ma persone che costituiscano un popolo nuovo, non
carne da macello, o conquistatori di altri attraverso la violenza e la
sopraffazione. E' sera e sarebbe difficile dire a questa folla: "Andate a
comprarvi il pane". E da che parte spuntano 12 ceste? Se le erano portate
vuote con sé? San Matteo vuol raccontare uno stile ed una preoccupazione che
trasmette alla sua comunità, ma vuol anche presentare l'immagine del nuovo
Mosé nel deserto. Gesù, spezzando il pane, sfama la folla e ciascuno riceve
ciò di cui ha bisogno per sfamarsi. E' una delle sei versioni, presenti nei
Vangeli, e ogni resoconto ha un messaggio particolare, che diventa il segno
di una nuova liberazione. In questo contesto siamo alla presenza di due
banchetti. Il primo, immediatamente precedente, ricorda il banchetto di una
società violenta e opulenta, radunato nel palazzo di Erode, che ha deciso la
morte di Giovanni Battista (14, 3-12). È una società corrotta, oppressiva e
sanguinaria che deve essere ripudiata da chi segue Cristo. Cristo costruisce
con coloro che lo seguono il nuovo popolo nel deserto. L'altro è il banchetto
di un mondo di poveri che si sviluppa nella gioia e nella festa poiché c'è
Gesù, ed è aperto a tutti.
- Gesù si inoltra nel deserto e dietro di lui
cammina una folla di poveri e di bisognosi, come all'uscita dall'Egitto,
desiderosi di raggiungere la propria libertà e liberarsi dalla malattia.
-
Egli ha compassione e condivide la sofferenza di chi non ha orientamento, né
fiducia, né futuro, né Parola di Dio ed è malato.
- Se davvero si
condivide, ci si deve prima di tutto accorgere dei problemi di ciascuno, dei
suoi bisogni primari e quindi della fame.
- Il problema primo è, agli
occhi di Gesù, la malattia, poiché è ciò che rende l'uomo instabile, fragile,
debole, e quindi non libero. Gesù infatti è venuto, fondamentalmente, a
ricostruire la pienezza della persona nella sua libertà e responsabilità.
- Sono i discepoli che si preoccupano della fame di queste persone e che non
hanno risorse. E fanno velocemente la verifica dei bisogni e decidono:
"Mandali a casa perché ciascuno provveda e comperi". E' il criterio del
sottomettersi alle strutture di economia o di ingiustizie. Il comperare non
esamina la vera povertà. Dice le condizioni per possedere, rifiutando ogni
altra alternativa che non sia di scambio.
- Gesù chiede loro di non
accettare il disimpegno: "Date voi stessi da mangiare" (v. 16). La novità è
regalare condividendo, è la gratuità. Gesù chiede che si faccia l'analisi
delle risorse, mentre tutti quelli che se ne rendono conto, dicono: "Sono
troppo poche, insignificanti, ridicole. Non c'è nient'altro da fare".
-
Gesù confida invece sullo sforzo di contribuire, per come si può, ed accetta
di operare su ciò che viene raccolto e portato. Portano cinque pani e due
pesci: il loro numero è sette, l'universale.
- A questo punto Gesù
benedice i cinque pani raccolti e li spezza (non li moltiplica. E' errato
parlare di "moltiplicazione dei pani", e infatti, nel Vangelo, di
moltiplicazione non se ne parla mai). "Si spezzano i pani e si distribuiscono
i pezzi". Ci si sfama con quello che ci è stato offerto, è sufficiente ed
avanza.
- Le 12 sporte piene sono il pane per il nuovo popolo che viene e
che ha sperimentato la gratuità.
- Il pane materiale richiama, con le
parole ed i gesti, la consacrazione della Messa dove Gesù offre se stesso
perché tutti si sfamino e tutti imparino a spezzare il pane. E' questo un
gesto fondamentale che andrebbe, ogni volta, valorizzato. Rappresenta la
nostra partecipazione al costruire gratuitamente il mondo, il nostro amore
alla famiglia, all'amico, al lavoro perché sia fatto bene e diventi un vero
servizio.
- Spezzare il pane è il segreto ed il criterio della pace. Lo
spezzare del pane è il vero significato della presenza di Gesù tra noi, il
messaggio di vita più profondo e l'avvio per quel culto spirituale quotidiano
a cui la Messa rinvia come al contenuto personale totale (Rm 12, 1ss).
-
Nel tempo della crisi si intravedono fatiche e si sottolineano comunque i
limiti, gli aumenti di prezzi, i disagi. Si continua a fare i conti per
quanto una famiglia deve spendere di più al mese per la benzina, per il gas e
la luce.
- Andrebbero riproposti, però anche, elementi di gratuità,
volontariato, operazioni di salvataggio, di solidarietà. Andrebbe stimolata
l'inventiva, il lavoro comune, la ricerca e la scuola, la formazione
professionale e il sostegno attraverso le proprie competenze. Lo spezzare il
pane della conoscenza è il più duraturo e il più necessario nella vita
quotidiana. |