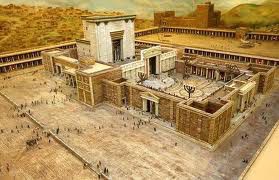|
Lettura del profeta Isaia 13, 4-11
In quei giorni. Isaia disse: Frastuono di folla sui monti,
simile a quello di un
popolo immenso. Frastuono fragoroso di regni, di nazioni
radunate.
Il Signore degli eserciti passa in rassegna un esercito di
guerra. Vengono da una terra lontana, dall’estremo orizzonte, il
Signore e
le armi della sua collera, per devastare tutta la terra.
Urlate,
perché è vicino il giorno del Signore; esso viene come una
devastazione da parte dell’Onnipotente. Perciò tutte le mani
sono
fiacche, ogni cuore d’uomo viene meno. Sono costernati.
Spasimi e
dolori li prendono, si contorcono come una partoriente.
Ognuno osserva sgomento il suo vicino: i loro volti sono
volti di fiamma. Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile,
con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per
sterminarne i peccatori. Poiché le stelle del cielo e le loro
costellazioni non daranno più la loro luce; il sole si oscurerà
al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Io punirò
nel mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità. Farò
cessare la superbia dei protervi e umilierò l’orgoglio dei
tiranni.
Al tempo del profeta Isaia (sec VIII) Babilonia non aveva un
particolare significato militare ed era soggetta agli Assiri.
Questo testo, di lotta e di sconfitta dei babilonesi, è molto
più vicino agli avvenimenti del sec VI quando Babilonia fu
distrutta da Ciro, persiano, nel 539 a.C. E’ perciò un testo
scritto, probabilmente dal terzo Isaia che trasfigura tale
avvenimento bellico in un castigo che il Signore infligge a
Babilonia mentre Babilonia diventa l’immagine simbolo di ogni
potere
dispotico. E’ perciò una rilettura teologica di un
avvenimento che aveva suscitato stupore in Israele. Babilonia
viene rappresentata come capitale di una grande potenza mondiale
pagana, contraria a Dio e disumana. La sua fine dimostra che il
Signore irrompe nella storia del mondo con il suo “giorno del
Signore”, portando le situazioni catastrofiche della
distruzione. I vv.2-5 raccontano i preparativi della battaglia
decisiva e i combattenti sono considerati i “consacrati”, truppe
di Dio e giustizieri a sua volta: “Io ho dato un ordine ai miei
consacrati; ho chiamato anche i miei prodi a strumento del mio
sdegno, entusiasti della mia grandezza”. (v. 3). Sono i soldati
delle tribù di Israele che combattono la battaglia di Jhwh.
Essi, prima di partecipare alla guerra, si sottoponevano a
determinati riti e dovevano osservare norme specifiche, compresa
l’astinenza sessuale(Deuteronomio 23,10-15). Il Signore, con il
suo popolo purificato, combatte
per liberare il mondo dalla tirannia e dall'oppressione. Il
racconto descrive l'angoscia e il terrore delle vittime, prima
ancora che l'esercito del Signore si
sia messo in marcia (vv.6-8). E’ l’espressione della paura e
il riconoscimento che veramente Dio è grande e che solo lui è
capace di potere e di potenza sulla terra.
Inizia quindi la narrazione del manifestarsi del Signore e le
conseguenze catastrofiche che egli porta (vv. 9-16) ma il testo
merita di essere letto per intero fino al v 22. Con questa
garanzia di presenza e di sostegno si apre il “giorno del
Signore” che diventa, in questo caso, garanzia e liberazione per
il popolo oppresso. Dio, che è il Signore dell’universo,
interviene con tutta la sua potenza, arrivando a coinvolgere le
stelle, il sole e la luna. Si descrive, attraverso immagini
drammatiche, la rovina che realmente cade su questa città,
orgogliosa e
tiranna sui popoli. Il messaggio, che si vuole trasmettere, è
di fiducia e di garanzia della presenza di Dio che non permette
ai potenti di arrivare a compiere il male contro il suo popolo.
E comunque, chi sviluppa violenza e opprime gli altri, è
destinato al fallimento. Alla fine la potenza di Dio esplode
nella liberazione.
|
Lettera di san
Paolo apostolo agli Efesini 5, 1-11a
Fratelli, Fatevi
dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate
nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha
dato se
stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave
odore. Di fornicazione e di ogni specie di impurità o di
cupidigia neppure si parli fra voi – come deve essere tra santi
– né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose
sconvenienti. Piuttosto rendete grazie! Perché, sappiatelo bene,
nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra –
ha in eredità il regno di Cristo e di
Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote: per queste cose
infatti l’ira di
Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate
quindi
niente in comune con loro. Un tempo infatti eravate tenebra,
ora
siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della
luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia
e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non
partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto.
La collocazione di questo brano, nella liturgia della 1°
domenica di Avvento, suggerisce ai credenti che vivono nella
storia del mondo, di essere lievito e luce, sale e sapienza,
presenza coraggiosa e generosa. In una storia che si
imbastardisce in male, violenza e dissoluzione, i cristiani sono
chiamati alla
novità, a non lasciarsi travolgere. Essi, che vivevano con
gli stessi criteri e la stessa mentalità dei pagani, se ne
possono rendere conto. Ora sono stati salvati dal Signore e
immessi in una comunità e in una luce nuova: sono un corpo solo,
la famiglia di Dio. Sono costituiti in unità con "un solo
Signore, una sola fede, un solo battesimo… un solo Dio e Padre
di tutti" (Ef 4,5-6), e quindi costituiscono l'unità del corpo
di Cristo (4,1-16). Viene quindi logico il confronto tra il
comportamento precedente alla conversione dei cristiani di
Efeso e la nuova vita secondo Gesù (Ef4,17-24). Continuando
questa riflessione, non ci si può dimenticare una particolare
responsabilità nella stessa comunità che esprime, insieme, la
ricchezza dei doni dello Spirito e la tensione verso una unità
più profonda (4,25-32) Così il testo del cap. 4 è un buon
antefatto che ci
aiuta a cogliere il messaggio di oggi. Paolo, infatti,
finisce, raccomandando la benignità, la misericordia “e
perdonandovi a vicenda come anche Dio, in Cristo, ha perdonato a
voi” (4,32). Si capisce, allora, il successivo incoraggiamento
che leggiamo oggi: “Fatevi, dunque, imitatori di Dio quali figli
carissimi”. L’impegno suggerito è una scelta progressiva,
“camminando nella carità”. Il camminare è un tipico linguaggio
ebraico che traduce “un comportamento, un seguire
una data norma”. E la misura, questa volta, non è solo legata
alla fede nel perdono del Padre, ma si dimensiona sull’esempio
concreto di Gesù che si è offerto al Padre per la nostra
riconciliazione. Paolo tiene ad esplicitare un comportamento
coerente, specificando che “la prostituzione, ogni
impurità, in genere, e l’avarizia” (5,3) vanno identificate
come idolatria e quindi rifiuto del vero Dio: “Perché,
sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè
nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di Dio”
(5,5). Comportarsi secondo queste scelte non costituisce solo
sbaglio o cattivo comportamento, ma diventa una vera forma di
culto idolatra perché è una totale
offerta di se stessi al denaro o ad alcune creature, come se
fossero Dio.
Ci sono anche preoccupazioni di correttezza nel linguaggio
(“volgarità, insulsaggini e trivialità”) che non fa riferimento
solo a buona educazione ma a”cose sconvenienti” che banalizzano
e “sporcano” la realtà, riconducendola a “ogni specie di
impurità”. L’alternativa è il rendere grazie. Solo in questo
modo ciascuno qualifica una presenza dignitosa e coerente che
vive con semplicità e gratitudine la propria esistenza, sa
accorgersi della presenza di Dio e dei suoi doni e accoglie
ogni persona con stima e rispetto. Sul linguaggio Paolo si
ferma molto poiché per ciascuno è questo il primo e il proprio
modo di presentarsi, è lo svelamento di ciò che siamo, è
l’immagine della propria interiorità. La correttezza, il
significato delle parole, la discrezione (“neppure si parli tra
di voi come dev’essere tra santi v.3”), la lealtà, la serietà di
contenuto e la non vuotezza qualificano uno stile e una dignità
non comune, riferimento alla somiglianza con Dio ed alla santità
che è stata offerta perché “siete luce nel Signore”. Il dono del
battesimo ci ha resi “luce” (Col1,12: “Ringraziate con gioia il
Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi
nella luce”). Rigenerati dalla forza di Dio, Paolo ricorda che
la vita deve giungere alla conclusione di operosità e
concretezza. E parla di “frutti”: “Ora il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità…. le opere delle
tenebre non danno frutto” (vv 9-11). Anche Gesù concludeva con i
frutti: “Fate dunque un frutto degno della conversione” (Mt
3,8). “Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e
gettato nel fuoco” (Mt3,10).
|
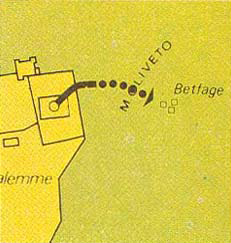 Luca 21, 5-28
Luca 21, 5-28