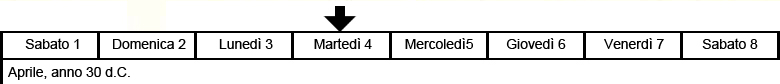
VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
10.07.2016
Matteo 22, 15-22
Riferimenti : primo libro di Samuele 8, 1-22a - SALMO
88 - Prima lettera a Timòteo 2, 1-8 |
| Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo. Beato
il popolo che ti sa acclamare: camminerà, Signore, alla luce del
tuo volto; esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella
tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con
il tuo favore innalzi la nostra fronte.Perché del Signore è il
nostro scudo, il nostro re, del Santo d’Israele. |
|
primo libro di Samuele 8, 1-22a
In quei giorni. Quando Samuele fu vecchio,
stabilì giudici d’Israele i suoi figli. Il
primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito
Abia; erano giudici a Bersabea. I figli di lui
però non camminavano sulle sue orme, perché
deviavano dietro il guadagno, accettavano regali
e stravolgevano il diritto. Si radunarono allora
tutti gli anziani d’Israele e vennero da Samuele
a Rama. Gli dissero: «Tu ormai sei vecchio e i
tuoi figli non camminano sulle tue orme.
Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro
giudice, come avviene per tutti i popoli». Agli
occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché
avevano detto: «Dacci un re che sia nostro
giudice». Perciò Samuele pregò il Signore. Il
Signore disse a Samuele: «Ascolta la voce del
popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non
hanno rigettato te, ma hanno rigettato me,
perché io non regni più su di loro. Come hanno
fatto dal giorno in cui li ho fatti salire
dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per
seguire altri dèi, così stanno facendo anche a
te. Ascolta pure la loro richiesta, però
ammoniscili chiaramente e annuncia loro il
diritto del re che regnerà su di loro». Samuele
riferì tutte le parole del Signore al popolo che
gli aveva chiesto un re. Disse: «Questo sarà il
diritto del re che regnerà su di voi: prenderà i
vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai
suoi cavalli, li farà correre davanti al suo
cocchio, li farà capi di migliaia e capi di
cinquantine, li costringerà ad arare i suoi
campi, mietere le sue messi e apprestargli armi
per le sue battaglie e attrezzature per i suoi
carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle
sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure
i vostri campi, le vostre vigne, i vostri
oliveti più belli e li darà ai suoi ministri.
Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne
prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani
e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le
serve, i vostri armenti migliori e i vostri
asini e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la
decima sulle vostre greggi e voi stessi
diventerete suoi servi. Allora griderete a causa
del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore
non vi ascolterà». Il popolo rifiutò di
ascoltare la voce di Samuele e disse: «No! Ci
sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti
i popoli; il nostro re ci farà da giudice,
uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre
battaglie». Samuele ascoltò tutti i discorsi del
popolo e li riferì all’orecchio del Signore. Il
Signore disse a Samuele: «Ascoltali: lascia
regnare un re su di loro».
Samuele ha coraggiosamente e lucidamente retto
il suo ruolo di giudice, difendendo le diverse
tribù dalla rapine e invadenze dei popoli
vicini. Si trova però ad una svolta importante
nella storia politica e religiosa d'Israele. Il
santuario dell'arca di Silo è stato distrutto e
l'unità è minacciata di fronte al crescere del
pericolo filisteo. Le tribù del nord non si
interessano delle difficoltà del sud e le tribù
ad oriente del Giordano, separate, riescono solo
a raccogliere i fuggiaschi delle tribù
occidentali. Il pericolo dei Filistei e il
comportamento molto anarchico delle tribù che
non si occupano a sufficienza delle difficoltà
che vivono le altre tribù sorelle fanno
ripensare a una nuova struttura di governo. Una
parte chiede un re (c'era già stato un tentativo
con Gedeone (Gdc 8,22s) e la conseguenza tragica
di Abimèlec (Gdc 9,1s), «come le altre nazioni».
Ma un'altra corrente si oppone, perché vuole
lasciare a YHWH, unico Signore d'Israele, la
cura di suscitare i capi che le circostanze
esigono, come ai tempi dei Giudici. Questo brano
segna il maturare della scelta. Samuele si
oppone al movimento del popolo che vuole un re
«come le altre nazioni» (cf.v 5). Egli pensa "Il
popolo d'Israele non può misurarsi con la
mentalità degli altri popoli, profana la propria
vocazione e missione, seguendo il loro esempio e
rifiutando il suo vero re, YHWH". Eppure il
Signore acconsente a malincuore (vv 8-9) e
obbliga Samuele ad avvertire Israele per tutti
gli inconvenienti che la monarchia comporterà
(vv 10-18). Si parla del diritto del re e lo si
esemplifica, presentandolo come una deformazione
del potere. E invece scoperte recenti indicano
che esso rappresenta la pratica dei regni
cananei anteriori a Israele. Il popolo è
pressato dai dubbi di una palese debolezza
poiché capisce che è necessario un comando
unitario e autorevole. Lo stesso fallimento dei
due figli di Samuele, posti come giudici, in
sostituzione del padre ormai vecchio, fa
individuare i pericoli della corruzione del
danaro senza la contropartita di una unità di
resistenza. Non si crede più nella istituzione
temporanea di un giudice, ma nella costituzione
di un governo, retto da un re, che coordini e
comandi e con il diritto della successione.
Samuele accetta le richieste del popolo. E Dio
stesso non si tira indietro. Sarà proprio il
Signore a scegliere via via i re: Saul, Davide,
Salomone. Infonderà il suo Spirito ma, nello
stesso tempo, obbligandoli ad essere
responsabili delle proprie azioni. I profeti
continueranno a suggerire il vero significato
del re come pastore e custode del popolo. Da una
discendenza regale nascerà il Messia. Mai come
in questi giorni si sta sperimentando l'esigenza
di una presenza politica che sappia reggere un
progetto di rinnovamento, di coerente sviluppo,
di operosità che rispetti il bene comune di
tutti e sorregga, soprattutto, le realtà dei più
disagiati perché senza lavoro e quindi senza
risorse. |
Prima lettera a Timòteo 2, 1-8
Carissimo, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande,
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per
i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo
condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a
Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro
salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio
e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo
Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa
testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io
sono stato fatto messaggero e apostolo – dico la verità, non
mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio
dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo
mani pure, senza collera e senza polemiche.
Ormai
Paolo si rende conto di dover reggere le diverse comunità che
fanno capo a lui, attraverso i discepoli, qui Timoteo. Paolo sta
sviluppando scelte pastorali poiché è il comportamento di vita
quotidiana che rende giustizia della fede e delle scelte che ai
credenti Gesù suggerisce. Perciò lo sviluppo della Chiesa è
affidato, molto più di prima, alla testimonianza operosa della
fede che non alla stessa predicazione: la testimonianza motiva
ed evidenzia efficacemente, nel mondo, i criteri di Gesù. In
questa lettera Paolo si dimostra molto affettuoso con Timoteo
per aiutarlo nel suo ruolo di capo della comunità cristiana. Nel
brano letto oggi. Paolo ricorda a Timoteo che deve educare alla
preghiera i suoi: il rapporto primo con Dio si sviluppa nella
preghiera. E in ciò che chiediamo, noi manifestiamo ciò che
siamo e ciò che accogliamo nel cuore: la fede, l'amore, la
maturazione e la consapevolezza della propria adesione alle
scelte di Gesù. Qui, tra l'altro, si intravede una preghiera
corale, liturgica. Essa deve essere universale: "Si facciano
domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli
uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere" (4
forme di preghiera e 3 riferimenti: il 7 sintetizza la creazione
del cielo e della terra, l'universo dell'uomo e del mondo)." E
il brano continua con affermazioni grandiose che sottolineano e
chiariscono le scelte che la comunità cristiana deve saper
maturare in sé: "Dio, nostro salvatore vuole che tutti gli
uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità" (e
"tutti" è ripetuto 4 volte, per richiamare l'orizzonte
dell'umanità). Così la preghiera cristiana è "per tutti gli
uomini" (2,4) e i cristiani sono chiamati alla collaborazione
perché tutti possano salvarsi. La preghiera si allarga alle
persone che hanno autorità poiché spetta a loro l'impegno di
mediazione, di equilibrio e di armonia nella comunità che
presiedono. Comunque si comportino, per il compito che hanno,
non vanno considerati nemici, ma hanno particolarmente bisogno
della forza di Dio per reggere nella pace. E il loro compito
viene specificato con molta lucidità: "perché possiamo condurre
una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio " (anche
qui viene specificato, declinandolo, il numero 4). Si prega
quindi per l'imperatore che non è un Dio, ma un uomo che ha
bisogno della forza di Dio. E si prega per chi ha potere perché
loro compito è provvedere al bene comune, senza lasciarsi
ingolosire da interessi di parte. Il compito fondamentale della
politica, infatti, è vivere nella pace, e la pace ebraica è lo
Shalom (armonia), avendo ciò che basta per vivere: rendere la
vita "serena e tranquilla per tutti". La conclusione di questo
splendido testo ci riporta all'atto della preghiera "disarmata",
coraggiosa e fedele all'amore di Gesù. "Voglio dunque che in
ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure,
senza collera e senza polemiche". Il tema della politica non può
essere estraneo alla sensibilità credente, anzi "La Chiesa ha
un'alta stima per la genuina azione politica; la dice "degna di
lode e di considerazione" (Concilio GS 75), l'addita come "forma
esigente di "carità" (Paolo VI OA 46). Riconosce che la
necessità di una comunità politica e di una pubblica autorità è
inscritta nella natura sociale dell'uomo e deriva dalla volontà
di Dio" (Conferenza Episcopale Italiana, la verità vi farà
liberi, Roma. 1995, 1102).
La vita del mondo è responsabilità
di tutti gli adulti. Vanno approfondite le analisi dei bisogni e
la solidarietà ampia degli interventi. Non si comincia
maledicendo, ma pregando per avere, ogni giorno, uno Spirito
nuovo; si opera nelle scelte morali; si incoraggiano i migliori,
i più competenti, i più saldi, accompagnando coloro che vi si
incamminano perché lottino per un "bene che sia sempre più bene
per tutti". Lo sfondo teologico è quello dell'unicità di Dio, di
Gesù che è mediatore universale e la garanzia che Dio vuole
salvi tutti gli uomini.
|
 |
Ecco il "denarius" d'argento (ingrandito 4 volte) recante
l'effige e il nome di Tibewrio Cesare Augusto.
...... e
rispose loro" Rendete Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio" |
 Matteo
22, 15-22 Matteo
22, 15-22
In quel tempo. I farisei se ne andarono e tennero consiglio per
vedere come cogliere in fallo il Signore Gesù nei suoi discorsi. Mandarono
dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a
noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù,
conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla
prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro.
Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero
meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Un giorno anche
Israele volle un re - "come avviene per tutti i popoli" - e lo chiese al
vecchio profeta Samuele. Parve a costui un torto fatto a Dio, quasi il popolo
di Dio volesse gestire la vita civile indipendentemente dai criteri morali
dati nella grande carta dei Comandamenti, dimenticando magari tutti i gesti
di salvezza che Dio aveva operato per loro. E li mise in guardia da un tal
pericolo, quasi presago di ciò che poi un giorno Gesù ebbe a denunciare con
sarcasmo: "Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i
capi le opprimono" (Mt 20,25). L'esplosiva situazione politica creatasi al
tempo di Gesù con la presenza dell'occupante Romano, alimentata dall'attesa
religiosa di un Messia liberatore politico, doveva o prima o poi approdare
polemicamente davanti a Lui: "E' lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?".
Tradotto significa: dobbiamo essere collaborazionisti o rivoluzionari? La
risposta di Gesù, certamente legata al contesto concreto immediato, ha anche
una indicazione universale che la comunità cristiana istruita da Matteo ha
voluto trasmettere a tutta la Chiesa. Questo insegnamento appunto ci
interessa. Appare immediato il disimpegno di Gesù a voler dirimere la
questione politica concreta, ponendosi su un altro piano, con una risposta
che va ben al di là.. di Cesare: "Rendete a Dio quello che è di Dio". Si fa
riferimento all'uomo nella sua più intima realtà, al di là dei ruoli storici
che riveste. Si potrebbe dire: l'uomo nei suoi valori umani, individuali e
sociali, nel suo profilo destinale, in quel che concerne la sua riuscita e
salvezza ultima. E' il piano del senso dell'uomo e della sua identità, della
dignità della persona umana, fondata su Dio e sul suo disegno eterno: "Dio
vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della
verità" (Epist.). La salvezza che Gesù porta è integrale, nel senso che
riguarda l'uomo totale nel suo rapporto con Dio, coi fratelli e col creato,
ossia nella sua umanità più profonda e vera; in questo senso è universale.
Chiaramente il piano in cui Gesù vuol porre la sua opera e il suo messianismo
è quello religioso, non politico. Dichiarerà esplicitamente davanti a Pilato:
"Il mio regno non è di questo mondo" (Gv 18,36). L'invito di Paolo è per la
preghiera: "Che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti
per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere,
perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a
Dio". Convivenza pacifica tra i due poteri, anzi servizio e apporto positivo
reciproco. Dice il Concilio: "La Chiesa di Cristo è come un sacramento o
segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano"
(LG 1). Aiuta l'unità tra gli uomini, ne è l'inizio e il segno, per
realizzare una vita civile più vivibile, basata sulla giustizia, la
solidarietà e il rispetto di ogni persona. In particolare la fede è stimolo,
motivazione e forza ad agire per il bene di tutti, come traduzione sociale di
quel comando della carità la quale sola ci rende simili a quel Dio che ama
ogni uomo con gratuità. Si parla di "carità politica", la più difficile da
attuare. E' facile che la politica slitti in qualche interesse di parte o in
ideologizzazioni, causa di gravi schiavitù imposte all'uomo. Oggi, di fronte
alle sfide della nostra cultura secolarizzata e, in apparenza, così
impermeabile a Dio, sembra sia richiesta anche più spiritualità e misticismo,
che ricostruisca una speranza di fronte ad un mondo disperato. Più stile di
comunione, anche, come forza attrattiva nei confronti di una umanità
disgregata e piena di lotte. Assieme ad una forte testimonianza di
solidarietà e servizio gratuito entro un mondo che soffre per troppo
interesse e potere. E' il modo oggi della Chiesa di ridivenire "anima del
mondo", abbandonando supplenze, "presenze" troppo compromesse, per
ridiventare lievito, sale e luce. In una parola: stile evangelico e santità.
Qualcuno ha scritto: "Il cristianesimo del XXI secolo o sarà santo o non
sarà", cioè finirà! Detto questo - cioè "a Dio quello che è di Dio" - si
inquadra bene anche quello che va dato a Cesare. La sfera politica attiene
all'ordine dei mezzi e dei fini intermedi, non è un assoluto, è parte della
realtà penultima, perché deve stare entro il quadro etico che le dà senso. La
politica deve essere in funzione dell'uomo, un servizio alla sua crescita e
libertà perché realizzi in pieno la sua vocazione globale, compresa quella
soprannaturale. La politica non può essere neutra; deve mirare a creare
condizioni con le quali ogni uomo possa sempre più facilmente realizzare se
stesso in consonanza e con l'apporto degli altri. Il bene comune - fine
primario della politica - è questa rete di opportunità e aiuti affinché
l'uomo divenga sempre più uomo. Il rispetto della persona richiede il
criterio della "sussidiarietà": lo statalismo - si dice con enfasi esagerata
"lo stato di diritto" - è comune in concezioni di destra e di sinistra. In
particolare va salvaguardata l'attenzione alla famiglia e alla sua primaria
libertà di educare. Non è sufficiente proclamare principi: bisogna che la
libertà di tutti e dei più deboli sia effettivamente garantita,
istituzionalizzata e realizzata. Discorso più complesso, ma non meno decisivo
- tra accoglienza e integrazione - è oggi quello della immigrazione, sempre
più irreversibile. Non esiste solo il criterio della sicurezza, ma anche il
diritto di chi chiede asilo e il necessario apporto economico e culturale che
ne viene ad una società come la nostra oggi anche in crisi demografica.
Bisogna che si rispetti l'ambito proprio della politica, della sua
opinabilità, come lo è sempre l'ambito dei mezzi. Evitare cioè
confessionalismo o fondamentalismo, oggi rinascenti e non solo tra culture
diverse dalle nostre. Nessuno deve pensare di avere il monopolio delle
formule politiche per salvare l'uomo. Le scelte politiche devono essere
frutto di collaborazione e di dialogo con quanti sinceramente cercano il bene
comune e determinano in concreto, in un certo tempo e luogo, formule più
corrispondenti alla dignità dell'uomo, ai bisogni immediati, alla
partecipazione più larga, tenendo conto anche dei più deboli. E' sulla base
di un pacchetto di valori prima e poi di programmi che si deve giocare la
collaborazione e l'unità degli uomini di buona volontà. In questo ambito
"politico" sappiamo che la Chiesa contemporanea ha elaborato una Dottrina
Sociale tra le più avanzate e le più stimate, anche dalla cultura laica. Uno
dei più bei documenti, di largo respiro ma al tempo stesso preciso in
formulazioni etiche concrete, è la "Centesimus Annus". O anche il Compedio
della Dottrina Sociale della Chiesa. Vale la pena che ogni serio credente ne
conosca direttamente il contenuto. Leggendola farà la scoperta gioiosa di chi
- se uomo sincero e pensoso - dovrà dire: guarda, vi è scritto proprio quello
che in fondo al cuore avevo sempre voluto in fatto di giustizia, solidarietà,
libertà e pace! |
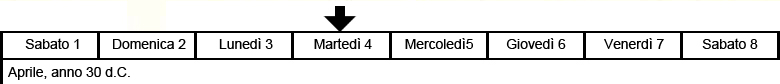

 Matteo
22, 15-22
Matteo
22, 15-22