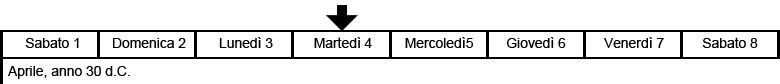
II domenica dopo la dedicazione
30 / 10/ 2016
Matteo 22, 1-14
Riferimenti : Isaia 25, 6-10a - Salmo 35 - Romani 4,
18-25 |
| Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! Signore,
il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua
giustizia è come le più alte montagne, il tuo giudizio come
l’abisso profondo: uomini e bestie tu salvi, Signore. |
|
Isaia 25, 6-10a
In quei giorni.
Isaia disse: / «Preparerà il Signore degli
eserciti / per tutti i popoli, su questo monte,
/ un banchetto di grasse vivande, / un banchetto
di vini eccellenti, / di cibi succulenti, di
vini raffinati. / Egli strapperà su questo monte
/ il velo che copriva la faccia di tutti i
popoli / e la coltre distesa su tutte le
nazioni. / Eliminerà la morte per sempre. / Il
Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
/ l’ignominia del suo popolo / farà scomparire
da tutta la terra, / poiché il Signore ha
parlato. / E si dirà in quel giorno: “Ecco il
nostro Dio; / in lui abbiamo sperato perché ci
salvasse. / Questi è il Signore in cui abbiamo
sperato; / rallegriamoci, esultiamo per la sua
salvezza, / poiché la mano del Signore si poserà
su questo monte”».
Nel testo di
Isaia, scritto probabilmente dopo l'esilio, si
profilano gli avvenimenti gioiosi della
conclusione definitiva della storia: il raduno
sul monte del Signore, il banchetto,
l'instaurazione del Regno eterno. L'immagine di
celebrare, con un pranzo, una vittoria viene,
qui, sviluppata in un incontro universale
fantastico: ci sarà un banchetto, organizzato da
Dio stesso, sul monte santo di Gerusalemme, a
cui sono invitati tutti gli uomini e le donne
dell'umanità a festeggiare la fine del mondo
vecchio e malvagio. Si favoleggia persino sul
menu e i rabbini, ripensando alla potenza di Dio
che ha ucciso un mostro marino, chiamato
Leviatan, dato quindi come "carne per il popolo
che abitava nel deserto" (salmo 74,14), hanno
concluso che la vivanda principale dei giusti
dovesse essere la carne di questo mitico pesce.
Perciò, in Israele, ancora oggi, alla cena del
venerdì sera, quando inizia sabato, si è soliti
mangiare pesce per richiamare a tutti gli uomini
pii il banchetto celeste che li attende.
- La
salvezza è universale,
- si esprimerà nella
comunione definitiva con Dio
- nell'immagine
del banchetto è richiamata l'esperienza umana
che diventa la parabola di Dio con il suo
popolo. Gesù userà spesso questo momento di
gioia poiché ognuno è nelle condizioni di
condividere con gli altri, nell'intimità e
nell'amicizia, la propria pienezza di festa e di
allegria;
- il profeta, nella sua
consapevolezza del tempo, non è ancora in grado
di parlare di risurrezione, ma annuncia la
scomparsa di una vita sconfitta, senza senso e
senza ideali;
- il banchetto, vissuto nella
gioia e nell'accoglienza, sarà allietato dalla
musica, dai canti, dalle danze;
- finalmente,
ma questo il profeta non lo sa ancora, poteva
supporre, nella sua rivelazione definitiva, un
incontro con quel Dio che già è stato incrociato
nella storia, pur nella difficoltà e
nell'oscurità della fede e della speranza. Ora
Egli, finalmente, è il trionfatore visibile
sulla morte e sulla sofferenza. Egli si
mostrerà, a faccia a faccia, senza veli. Senza
lacrime, finalmente, sarà il volto dei suoi
fedeli. È il messaggio che ci viene da Gesù,
annunciato continuamente da Paolo: "La morte è
stata inghiottita nella vittoria" (1Cor 15,54) e
ripresentato nella "visione dei cieli nuovi e
terra nuova" dell'Apocalisse (cap 21).
|
Romani 4, 18-25
Fratelli, Abramo
credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così
divenne «padre di molti popoli», come gli era stato detto: «Così
sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella fede, pur
vedendo già come morto il proprio corpo – aveva circa cento anni
– e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non
esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria
a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era
anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu
accreditato come giustizia.
E non soltanto per lui è stato
scritto che «gli fu accreditato», ma anche per noi, ai quali
deve essere accreditato: a noi che crediamo in colui che ha
risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato
consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato
risuscitato per la nostra giustificazione
Nella lettera ai Romani San Paolo, parlando della fede, presenta
Abramo come un testimone fedele, coraggioso e fidato. Abramo,
contro ogni speranza, ha continuato a sperare di poter avere un
figlio da Sara, la moglie amata, poiché il Signore stesso glielo
aveva promesso. Eppure aveva sotto gli occhi la crisi possibile
di questa speranza, invecchiando lui e Sara, senza ombra o
presagio di compimento. Abramo continua a fidarsi e si rinsalda.
Convinto di Dio e della sua Parola, attende e questo lo fa
crescere agli occhi di Dio come uomo giusto. Noi stessi che
crediamo in Gesù diventiamo, come Abramo, coloro a cui "fu
accreditato come giustizia". La fedeltà di Abramo gli procurerà,
alla fine, Isacco, il figlio della promessa, ma anche una
discendenza che da questo figlio nascerà. La nostra fede in Gesù
non ha solo, come contenuto, la nascita di un figlio, ma la
consapevolezza che Gesù è risuscitato, Lui "il quale è stato
messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la
nostra giustificazione". La coscienza del credente deve portare,
davanti alle situazioni difficili della violenza e del male,
l'impegno di credere in una circolazione di beni e di fedeltà
che nasce da Dio e si distribuisce, giorno per giorno, nel cuore
di ciascuno. Il credere in questa ricchezza in noi e negli altri
ci deve portare ad osare nella speranza, ci deve far maturare
per operare e quindi credere a che la speranza di Dio si compia
ogni giorno nel cuore di ciascuno. Le tante paure esistenti, le
tante diffidenze, le tante ritrosie della solidarietà possono
venire abbattute dalla coscienza della presenza di Dio che è
amore e quindi è più grande di qualunque paura, di qualunque
diffidenza e di qualunque egoismo.
|
 Matteo
22, 1-14 Matteo
22, 1-14
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con
parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con
quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei
buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai
propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini
e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di
nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi
delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze”. Usciti
per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e
buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere
i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli
disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello
ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono
chiamati, ma pochi eletti».
La parabola della lettura
odierna è detta "della grande cena", perché ci presenta un sontuoso banchetto
che un re ha imbandito per le nozze di suo figlio e a cui ha invitato molte
persone ragguardevoli. Ma queste, nonostante due ripetuti e insistenti
inviti, non vogliono andare, anzi alcuni se la prendono con gli stessi
messaggeri insultandoli e arrivando persino ad ucciderli! Il re allora
punisce molto pesantemente quegli assassini e manda di nuovo dei servi ad
invitare chiunque, "buoni e cattivi", espressione semitica per dire: proprio
tutti. Così la sala finalmente si riempie di commensali; ma il re vede uno
privo dell'abito nuziale e, non avendone avute spiegazioni, ordina ai suoi
servi di legarlo mani e piedi e gettarlo fuori nelle tenebre. Com'è noto, la
parabola è un racconto fittizio, che non va interpretato in ogni suo
particolare, ma di cui va colta la cosiddetta "punta", il centro verso cui
tutto converge; nel testo in esame sono presenti due parabole (una più lunga
e una molto breve), in cui il punto focale è rispettivamente: il contrasto
tra chi rifiuta e chi accoglie l'invito del re; la punizione di chi si è
presentato al banchetto in veste inadeguata. Vediamo ora di spiegare le due
parabole. Il tema del banchetto e delle nozze è frequentissimo nell'Antico
Testamento per indicare il regno di Dio: ne è un chiaro esempio il brano di
Isaia 25, 6-10a, che costituisce la 1° lettura di questa liturgia; lo dice
esplicitamente Gesù nell'introdurre i due racconti: "Il regno dei cieli è
simile a un re che fece un banchetto di nozze..." (v.2). Il regno dei cieli è
poi strettamente collegato alla dimensione della festa e della gioia:
"rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza", dice ancora Isaia al v.9; e
il banchetto nuziale su cui verte la parabola porta sempre con sé l'idea di
un grande gioioso festeggiamento per quella bellissima realtà che è l'amore
di due sposi. Allora fuor di metafora il discorso è chiaro: il re è Dio che
vuole la partecipazione più ampia possibile, anzi la partecipazione di tutta
l'umanità, alla festa e alla gioia del suo regno, alla comunione con Lui e
con il Figlio Gesù. Ma molti, anzi tutti i primi invitati, rifiutano: chi
sono? Nel contesto storico in cui viene narrata la parabola (gli ultimi
giorni di Gesù a Gerusalemme, dove avviene lo scontro con le autorità
giudaiche che lo porterà alla morte), questi primi invitati sono i membri del
popolo eletto, Israele, che ha rifiutato dapprima i profeti (i primi servi
inviati dal re), giungendo addirittura ad ucciderne alcuni! e poi anche la
predicazione e l'annuncio del Nazareno (adombrato nel secondo invio di
messaggeri), rivolto a tutti senza distinzione: piccoli, poveri, peccatori,
ignoranti, gente esclusa dalla comunità religiosa ebraica. Il rifiuto però
non è senza conseguenze: nella parabola si parla di un re che manda a morte
gli assassini e addirittura incendia la loro città (è qui evidente
l'allusione alla terribile distruzione di Gerusalemme e del tempio ad opera
dei Romani nel 70 d.Cr.). E' forse una punizione eccessiva? No, se pensiamo
alla natura del grandissimo dono che Dio fa agli uomini chiamandoli al suo
regno, cioè alla comunione con sé, e al senso della punizione nella Bibbia.
Come scrive l'emerito card. Martini nel suo bel libro "Perché Gesù parlava in
parabole?" (p.97), "Gesù vuole ribadire che c'è un assoluto primato di Dio
rispetto alla storia, all'uomo, alle situazioni, ai beni.......Dio è il Bene
supremo, e questo rende inevitabile il giudizio, dal momento che non è un
bene facoltativo, ma assoluto e il suo contrario è il non bene dell'uomo.
L'offerta di questo bene è talmente pressante (lo stesso essere di Dio che si
rivela) da porre l'uomo che lo respinge nello stato di dannazione, nella
miseria esistenziale più profonda.......La mia esistenza, con i suoi talenti,
è una possibilità assolutamente seria che Dio mi offre per essere nel regno,
nella pienezza della comunione con Lui e con gli altri; oppure diventerà
rifiuto di questa pienezza." Quando, negli anni 80 d.Cr., il redattore del
primo vangelo ("secondo Matteo"), si trovò di fronte a questo testo
(tramandato dapprima oralmente e poi per iscritto), la comunità cristiana,
che al contrario degli Ebrei aveva accolto l'invito di Gesù, aveva ormai alle
spalle diversi decenni di storia. Essa si mostrava troppo fiduciosa in se
stessa, illudendosi di possedere una sorta di "cambiale" per il regno; a
causa di questa falsa sicurezza l'impegno di vita era diminuito e serpeggiava
un certo lassismo. L'evangelista decise allora di attualizzare la parabola
aggiungendo il secondo racconto relativo all'abito nuziale, che riflette
l'uso del tempo di fornire una veste adeguata al banchetto ad invitati che
arrivavano da lunghi viaggi, impolverati e in disordine; l'uomo trovato senza
di essa evidentemente non l'ha voluta e si è presentato in modo non consono
alla situazione. |