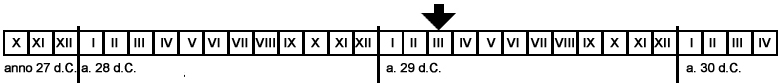
IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
25 SETTEMBRE 2016
Giovanni 6, 51-59
Riferimentri : Lettura del libro dei Proverbi 9, 1-06 -
SALMO 33 - Prima lettera ai Corinzi 10, 14-21 |
| Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua
lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si
rallegrino. Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti
non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo
ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. |
|
Lettura del libro dei Proverbi 9,
1-6
La sapienza si è costruita la sua casa, /
ha intagliato le sue sette colonne. / Ha ucciso
il suo bestiame, ha preparato il suo vino / e ha
imbandito la sua tavola. / Ha mandato le sue
ancelle a proclamare / sui punti più alti della
città: / «Chi è inesperto venga qui!». / A chi è
privo di senno ella dice: / «Venite, mangiate il
mio pane, / bevete il vino che io ho preparato.
/ Abbandonate l’inesperienza e vivrete, / andate
diritti per la via dell’intelligenza».
La prima lettura è tratta dai
Proverbi, un libro in cui viene descritta la
Sapienza. La Sapienza è come l'albero della
vita, si presenta come una signora, offrendo
l'immagine dell'innamoramento: è dono di Dio, da
ricercare in continuazione senza raggiungerla
mai in pieno. La Sapienza rivolge all'intera
umanità l'invito a un banchetto. Il pranzo è
simbolo di comunione e di intimità. C'è poi una
parte successiva, che non leggiamo oggi,
dominata dalla "follia", la personificazione
della malvagità che con l'attrattiva del
proibito è sempre suggestiva. "Sapienza" è in
ebraico al plurale. La sua attività si manifesta
così: Ha intagliato le sette colonne",
dimostrando di costruirsi un edificio elegante
per la presenza delle colonne; il numero sette
richiama l'idea di un palazzo finito. La
Sapienza ha una dimora fissa e signorile.
All'intorno la presenza di cibo e bevande denota
la ricchezza. La preparazione di un ambiente
idoneo servirà ad accogliere gli invitati,
allestendo tutto il necessario per rendere
plausibile tale invito. La seconda parte del
brano vede la Sapienza che dispone i suoi servi
in punti strategici, dove si collocano i
banditori: ella si preoccupa di far giungere
l'invito anche lontano. "I più alti punti della
città" indicano che il messaggio giunge anche
nei luoghi più remoti. E' arrivato anche a noi!
L'invito viene rivolto a tutti, anche a coloro
che sembrerebbero meno idonei; si parla di
"ingenuo" e di "inesperto" per indicare una
persona disponibile, ben lontana dall'arroganza
di chi si illude di sapere tutto. Meta di tale
istruzione, che interessa tutta l'esistenza, è
la vita, intesa come pienezza di realizzazione
che si raggiunge al termine del cammino, di cui
la Sapienza lascia intendere di essere esperta
conoscitrice "via dell'intelligenza". Tutto è
costruito su questi tre punti: "Sapienza - vita
- cammino": il banchetto a cui la Sapienza
invita è un mezzo per attingere forza per
riprendere il cammino e arrivare alla vita.
Quindi tutti se lo vogliono, possono essere
beneficati da lei. Per rispondere alla domanda
iniziale, non è un peso morale, essere corretti
e onesti, equivale a rispondere all'esigenza
della Sapienza, alla felicità, ma non ce la
facciamo da soli, occorre partecipare al
banchetto e assumerne le energie. |
Prima lettera ai Corinzi 10, 14-21
Miei cari, state lontani dall’idolatria. Parlo come a persone
intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico: il calice
della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con
il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse
comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi
siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all’unico pane. Guardate l’Israele secondo la carne: quelli che
mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con
l’altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata
agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No, ma
dico che quei sacrifici sono offerti ai demòni e non a Dio. Ora,
io non voglio che voi entriate in comunione con i demòni; non
potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni; non
potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei
demòni.
Nella sua prima lettera ai Corinzi,
Paolo unisce insieme verità di fede e suggerimenti pastorali. E'
un attento osservatore dei fatti della vita quotidiana e
suggerisce che i credenti si convertano alla vita e alla Parola
di Gesù. La fede, infatti, comporta uno stile di vita coerente
con le sue scelte ed obbliga ad una revisione non solo i pagani,
che si sono convertiti, ma lo stesso popolo d'Israele, legato
alla legge di Mosè. Un problema pastorale, per noi curioso, è
già stato iniziato al cap.8: ci si interroga sul proprio
comportamento in rapporto con la carne comprata al mercato o la
carne utilizzata da parenti che non sono cristiani e che hanno
invitato a mangiare a casa loro amici e parenti cristiani. Il
problema si pone perché tutta la carne, anche quella in vendita
sul mercato, proviene da sacrifici offerti agli idoli. Paolo
sviluppa alcune riflessioni teologiche. In fondo gli dei pagani
non esistono e quindi il mangiare carne offerta agli idoli è
inoffensivo. Ma d'altro lato l'adesione a pratiche idolatre
suppongono la fede non tanto in Dio ma ad un antagonista di Dio
che perciò è un demonio. In conclusione, se i cristiani non
debbono partecipare al culto degli idoli, tuttavia non sono
obbligati ad indagare su eventuali operazioni cultuali
precedenti, qualora siano stati invitati ad un banchetto. Se non
sanno la provenienza della carne, non si preoccupino. Se invece
ne sono consapevoli, allora se ne astengano, soprattutto se la
segnalazione viene da un fratello o una sorella nella fede, per
non offendere la debolezza della fede di qualcuno che potrebbe
scandalizzarsi (10,23-32).
Ma, riprendendo la problematica
del capitolo 8, Paolo si preoccupa che non si ritorni alla
idolatria. Partecipare ai banchetti idolatrici fa conseguire una
vicinanza con la divinità che l'idolo rappresenta: attraverso il
cibo noi costituiamo un incontro, una presenza del divino nel
fedele. Viene ricordata l'Eucarestia con una formulazione già
arcaica, che fa riferimento alle iniziali descrizioni sintesi,
esistenti nella prima Comunità cristiana: sottolineano i tratti
comunitari e la partecipazione: "Il calice della benedizione che
noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo?
E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo
di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all'unico pane"
(10,16-17). E' la sintesi dell'ultima Cena, maturata come
adesione piena e totale con Gesù per cui diventiamo, con Lui, un
solo corpo. E noi, insieme, siamo la Chiesa, presenza di Gesù
nel mondo. In tal modo noi ritroviamo, a livello altissimo, un
legame tra credenti e l'unità al Padre attraverso Gesù.
Dall'idolatria come culto bisogna stare attenti poiché la si può
vivere anche oggi come stile di vita e come metodo di scelte,
quando la Parola di Gesù viene dimenticata nelle nostre scelte
economiche, di convivenza, di rapporti sociali fino alle
lacerazioni ideologiche che portano alla dissoluzione di
condivisioni, alla violenza, alla distruzione della persona e
dei popoli. E si vive come se Dio non esista.
|
 Giovanni
6, 51-59 Giovanni
6, 51-59
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a
discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete
in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me
e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è
il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». / Gesù disse queste cose,
insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Oggi è Gesù che ci
parla dell'Eucaristia. Dell'Eucaristia come pane di vita per stare alle Sue
parole: "io sono il pane vivo disceso dal cielo". Sono espressioni che per un
verso potremmo ritenere di capire, avendo fatto un po' di catechismo. La
Parola di questa domenica è un chiaro invito a superare la superficialità e
il fraintendimento nei confronti dell'Eucaristia che stiamo celebrando. Nel
libro dei Proverbi si dice che "la sapienza si è costruita la sua casa, ha
intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il
suo vino e ha imbandito la sua tavola". La sapienza divina si costruisce una
casa nella quale siamo invitati a bere "il suo vino", sedendo alla "sua
tavola". Concludendo con un invito insistente: "abbandonate l'inesperienza e
vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza". Questo invito a
guardare con intelligenza al banchetto che Dio stesso ci ha preparato ci
obbliga oggi a guardare con più intelligenza alla realtà eucaristica alla
quale stiamo partecipando. Apparteniamo a un'epoca che ci impegna a
riappropriarci delle realtà che dicono la nostra fede. E tra queste
certamente c'è l'Eucaristia: il gesto più grande che Gesù stesso ci ha
chiesto di ripetere in Sua memoria: "Fate questo in memoria di me" (Lc
22,19). Quel gesto che più immediatamente chiamiamo comunione, fare la
comunione. Un gesto che oggi molti ripetono con frequenza. Talvolta anche in
modo scontato e superficiale. Non ci si deve stupire, pertanto, se riandando
al finale del capitolo VI di Giovanni dal quale è tratto anche il brano di
oggi, dovessimo provare anche noi un certo disagio, uno sconcerto, davanti
all'invito di Gesù, fatto ai Giudei e ai Suoi che Lo stavano ad ascoltare, a
mangiare la Sua carne e a bere il Suo sangue. Così che alcuni cominciarono ad
andarsene dicendo "questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?" (6,62).
Anche Paolo, nell'Epistola registra un disagio nei confronti dell'Eucaristia.
Il pericolo dell'idolatria. Il rischio di un travisamento di questo gesto che
Gesù ha totalmente rimesso nelle nostre mani: "state lontani dall'idolatria.
Parlo come a persone intelligenti". Paolo sta invitando i cristiani di
Corinto ad un atto di maggiore consapevolezza, a una presa di coscienza, come
diremmo noi: "giudicate voi stessi quello che dico: il calice della
benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di
Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di
Cristo?". |