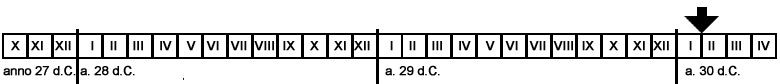
VI DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
17 febbraio 2019
Luca 17, 11-19
Riferimenti : Isaia 56, 1-8 - Salmo 66 - Romani 7,
14-25a |
| Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi
faccia splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra la
tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le
nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con
rettitudine, governi le nazioni sulla terra. |
|
In quei giorni. Così dice il
Signore: «Osservate il diritto e praticate la
giustizia, / perché la mia salvezza sta per
venire, / la mia giustizia sta per rivelarsi». /
Beato l’uomo che così agisce / e il figlio
dell’uomo che a questo si attiene, / che osserva
il sabato senza profanarlo, / che preserva la
sua mano da ogni male. / Non dica lo straniero
che ha aderito al Signore: / «Certo, mi
escluderà il Signore dal suo popolo!». / Non
dica l’eunuco: / «Ecco, io sono un albero
secco!». / Poiché così dice il Signore: / «Agli
eunuchi che osservano i miei sabati, /
preferiscono quello che a me piace / e restano
fermi nella mia alleanza, / io concederò nella
mia casa / e dentro le mie mura un monumento e
un nome / più prezioso che figli e figlie; /
darò loro un nome eterno / che non sarà mai
cancellato. / Gli stranieri, che hanno aderito
al Signore per servirlo / e per amare il nome
del Signore, / e per essere suoi servi, / quanti
si guardano dal profanare il sabato / e restano
fermi nella mia alleanza, / li condurrò sul mio
monte santo / e li colmerò di gioia nella mia
casa di preghiera. / I loro olocausti e i loro
sacrifici / saranno graditi sul mio altare, /
perché la mia casa si chiamerà / casa di
preghiera per tutti i popoli». / Oracolo del
Signore Dio, / che raduna i dispersi d’Israele:
/ «Io ne radunerò ancora altri, / oltre quelli
già radunati».
Con questo
passo entriamo nel mondo del terzo Isaia, la cui
preoccupazione forte è come aiutare la comunità
che torna nel paese a ricostruirsi su principi
di giustizia.nIl terzo Isaia ha molto presente
la visione di speranza del profeta che lo
precede. Già nell’inizio di nquesto capitolo
vediamo la sua insistenza sui temi della
giustizia e del diritto. Ma il secondo versetto
propone quella che è la visione che anima tutta
la sua opera profetica: l’inclusività e il senso
di appartenenza. Questi versetti costituiscono
la prima metà di una cornice letteraria che
racchiude il libro profetico, l’altra metà è
situata in 66:18-23 (sappiamo che il v. 24
andrebbe collocato altrove, e forse è di altra
mano, così duro com’è). L’intera cornice parla
di un Dio che si propone di “raccogliere tutte
le nazioni” e persino di scegliere i suoi
sacerdoti tra coloro che vengono da più lontano.
Dunque se l’inizio è una sorta di invito a non
sentirsi esclusi per nessun motivo legato alla
propria identità, la conclusione mostra un Dio
che opera un rimescolamento della comunità di
fede attraverso l’immissione di persone esterne
che ne diventano addirittura le guide. Perché ci
interessa questo testo nel percorso di
riflessione sull’omosessualità? In primo luogo
perché si tratta di una visione molto ampia di
accoglienza e inclusività: la comunità di fede
che risponde all’invito di Dio è composta da
persone di ogni provenienza, e nessuna di esse
viene demonizzata. In secondo luogo perché
l’eunuco rappresenta una condizione accostabile
a
quella omosessuale, se non altro per essere
una persona che non può avere una discendenza,
ed è confinato in una condizione di impurità ed
esclusione |
Romani 7, 14-25a
Fratelli,
sappiamo che la Legge è spirituale, mentre io sono carnale,
venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che
faccio: infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che
detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la
Legge è buona; quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che
abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non
abita il bene: in me c’è il desiderio del bene, ma non la
capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio,
ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio,
non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque
io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male
è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di
Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che combatte
contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge
del peccato, che è nelle mie membra. Me infelice! Chi mi
libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per
mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!
Da
ragazzina il mio parroco mi aveva consegnato questo capitolo 7
della lettera ai Romani come parola da meditare dopo la
confessione. Da allora il dramma che Paolo qui descrive, mi
accompagna e mi interroga: il dissidio interiore per cui compio
ciò che non voglio è solo del cosiddetto uomo vecchio, che la
grazia di Cristo ha cancellato? L'uomo nuovo non vive più questa
ambiguità? Il nostro non è più un corpo votato alla morte, è un
corpo redento che si offre a Dio come culto, come offerta
gradita! E allora... perché è ancora così vivace in noi la
situazione del non fare quello che intuiamo giusto, buono? Paolo
non dà immediatamente soluzioni e risposte; descrive
minuziosamente questo dissidio interiore e esteriore e lo lascia
a noi. Una rappresentazione emblematica del già e non ancora, di
una salvezza arrivata definitivamente, ma non ancora compiuta
nella vita personale di ciascuno. Quel non ancora determinato
dalla libertà della persona di scegliere o non scegliere l'amore
di Dio. Spazio per la ricerca, per intuire la promessa e
desiderarla, per dire sì ad un dono senza superficialità. Luogo
interiore dove la persona e lo Spirito si incontrano per fare
spazio all'amore di Dio. Questa lancinante situazione
dell'umanità apre il capitolo della vita nello Spirito e ci
introduce pienamente nella vita teologale. Tutta la
riflessione si conclude con un'invocazione di lode a Dio. Come
nei salmi, che dopo aver narrato e dato spazio al lamento o alla
supplica a volte anche un po' arrabbiata del salmista, si
concludono con una lode piena, diretta a Dio! Signore, fa' che
lo Spirito in me oggi lodi e renda grazie a te, per mezzo di
Gesù Cristo!
|
 Luca
17, 11-19 Luca
17, 11-19
In quel tempo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore
Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli
vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono
purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un
Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri
nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’;
la tua fede ti ha salvato!».
Dieci lebbrosi fermi a
distanza; solo occhi e voce; mani neppure più capaci di accarezzare un
figlio: Gesù, abbi pietà . E appena li vede (subito, senza aspettare un
secondo di più, perché prova dolore per il dolore del mondo) dice: Andate
dai sacerdoti. È finita la distanza. Andate. Siete già guariti, anche se
ancora non lo vedete. Il futuro entra in noi molto prima che accada, entra
con il primo passo, come un seme, come una profezia, entra in chi si alza e
cammina per un anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio domani. Solo
per questo anticipo di fiducia dato a ogni uomo, perfino al nemico, la
nostra terra avrà un futuro. Si mettono in cammino, e la speranza è più
forte dell'evidenza. Ma chi vuol stare con l'evidenza si rassegni ad essere
solo il custode del passato. Si mettono in cammino e la strada è già
guarigione. E mentre andavano furono guariti. Il cuore di questo racconto
risiede però nell'ultima parola: la tua fede ti ha salvato. Il Vangelo è
pieno di guariti, un lungo corteo gioioso che accompagna l'annuncio. Eppure
quanti di questi guariti sono anche salvati? Nove dei lebbrosi guariti non
tornano: si smarriscono nel turbine della loro felicità, dentro la salute, la
famiglia, gli abbracci ritrovati. E Dio prova gioia per la loro gioia come
all'inizio aveva provato dolore per il loro dolore. Non tornano anche perché
ubbidiscono all'ordine di Gesù: andate dai sacerdoti. Ma Gesù voleva essere
disubbidito, alle volte l'ubbidienza formale è un tradimento più profondo.
«Talvolta bisogna andare contro la legge, per esserle fedeli in profondità»
(Bonhoffer). Come fa Gesù con la legge del sabato. Uno solo torna, e passa da
guarito a salvato. Ha intuito che il segreto non sta nella guarigione, ma nel
Guaritore. È il Donatore che vuole raggiungere non i suoi doni, e poter
sfiorare il suo oceano di pace e di fuoco, di vita che non viene meno. Nel
lebbroso che torna importante non è l'atto di ringraziare, quasi che Dio
fosse in cerca del nostro grazie, bisognoso di contraccambio; è salvo non
perché paga il pedaggio della gratitudine, ma perché entra in comunione: con
il proprio corpo, con i suoi, con il cielo, con Cristo: gli abbraccia i piedi
e canta alla vita. I nove guariti trovano la salute; l'unico salvato trova
la salute e un Dio che fa fiorire la vita in tutte le sue forme, che dona
pelle di primavera ai lebbrosi, un Dio la cui gloria non sono i riti ma
l'uomo vivente. Ritornare uomini, ritornare a Dio: sono queste le due tavole
della legge ultima, i due movimenti essenziali d'ogni salvezza.
|