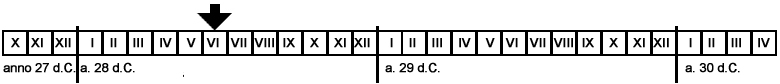
V domenica dopo il martirio di giovanni
9 settembre 2019
Lc 6, 27-38
Riferimenti :Isaia 56, 1-7 - Salmo 118 - Romani 15, 2-7 |
| Signore, conservo nel cuore le tue parole.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua
parola. Con tutto il mio cuore ti cerco: non lasciarmi deviare
dai tuoi comandi. |
|
Is 56, 1-7
Così dice il Signore:
«Osservate il diritto e praticate la giustizia,
perché la mia salvezza sta per venire, la mia
giustizia sta per rivelarsi». Beato l’uomo che
così agisce e il figlio dell’uomo che a questo
si attiene, che osserva il sabato senza
profanarlo, che preserva la sua mano da ogni
male. Non dica lo straniero che ha aderito al
Signore: «Certo, mi escluderà il Signore dal suo
popolo!». Non dica l’eunuco: «Ecco, io sono un
albero secco!». Poiché così dice il Signore:
«Agli eunuchi che osservano i miei sabati,
preferiscono quello che a me piace e restano
fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia
casa e dentro le mie mura un monumento e un nome
più prezioso che figli e figlie; darò loro un
nome eterno che non sarà mai cancellato. Gli
stranieri, che hanno aderito al Signore per
servirlo e per amare il nome del Signore, e per
essere suoi servi, quanti si guardano dal
profanare il sabato e restano fermi nella mia
alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li
colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I
loro olocausti e i loro sacrifici saranno
graditi sul mio altare, perché la mia casa si
chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli».
Isaia 56,1-7
Il testo di
oggi inizia il messaggio di un profeta anonimo
che passa sotto il nome di Terzo Isaia e fa
riferimento al ritorno degli ebrei dall'esilio
nella terra di Giuda (sec VI). Il clima è
diverso. Esisteva, prima dell'esilio, un
esclusivismo esigente e duro, destinato a
mantenere pura la propria fede e a non
mescolarsi con altre divinità. L'esperienza del
popolo o i matrimoni dei sovrani con donne
straniere dimostrano a sufficienza che i
matrimoni con straniere facevano deviare dalla
fede. Perciò il libro del Deuteronomio,
attribuito a Mosè, ma in realtà scritto nel
sec.VII-VI a.C. obbliga: "Con gli stranieri non
stringerai alcuna alleanza e nei loro confronti
non avrai pietà. Non costituirai legami di
parentela con loro, non darai le tue figlie ai
loro figli e non prenderai le loro figlie per i
tuoi figli, perché allontanerebbero la tua
discendenza dal seguire me, per farli servire a
dèi stranieri" (7,2-4). La liberazione da
Babilonia ha aperto molte speranze, ma
l'esperienza faticosa della convivenza, con un
popolo pagano e vincitore, ha obbligato a grandi
riflessioni e maturazioni. E comunque è stata
una convivenza con un popolo straniero di alta
cultura. La convivenza dell'esilio ha fatto loro
ripensare ad atteggiamenti diversi. Ha fatto
superare paure e pregiudizi. Anche a Babilonia,
hanno incontrato uomini e donne di fiducia,
giusti, portatori e portatrici di valori
condivisi. Ma non tutti vivono il ritorno così.
Altri, invece, anche tra le guide politiche e
religiose, hanno ripreso diffidenze e sospetti
poiché erano rimasti pregiudizi pericolosi, e
ritenevano che la vera fede consistesse nel
rifiutare ogni straniero. |
Rm 15, 2-7
Fratelli, ciascuno di
noi cerchi di piacere al prossimo nel bene, per edificarlo.
Anche Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come
sta scritto: «Gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me».
Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per
nostra istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della
consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la
speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi
conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti,
sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce
sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo
accolse voi, per la gloria di Dio.
Romani
15,2-7
Questo capitolo inizia con il riferimento ai forti ed
ai deboli: "Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare
le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi" Paolo è
preoccupato delle tensioni esistenti tra quelli che lui chiama i
forti e quelli che chiama deboli.
I forti erano coloro che
ritengono sorpassate le osservanze dell'antica legge poiché ciò
che conta è credere in Cristo, nella sua parola e nel suo
progetto di vita. I deboli sono coloro che, legati ancora alle
tradizioni religiose ebraiche degli antichi, conducono una vita
austera, si privano anche di piaceri leciti, continuano nella
prescrizione dei cibi impuri, praticano la circoncisione. I
deboli giudicano i forti come persone superficiali. I forti, a
loro volta, disprezzano i deboli e li trattano da retrogradi,
ignoranti, nostalgici. Paolo, che si colloca tra i forti (lo
dice all'inizio di questo capitolo), raccomanda carità e
rispetto reciproco nella comunità cristiana. Si deve
particolarmente fare del bene al fratello, anche disposti a
limitare la propria piena libertà se questo è richiesto
dall'amore dell'altro. Difatti Paolo riporta l'insegnamento di
Gesù non solo espresso nelle parole ma anche esemplificato nel
suo comportamento. Per la salvezza degli uomini che il Padre
vuole, egli va incontro a disagi e ingiurie e vi si sottopone
per amore dei fratelli che vuole aiutare. Nella comunità
cristiana sono fondamentali la perseveranza e la consolazione
reciproca e queste sono date da Dio. In un clima di preghiera
perseveranza e consolazione rendono gloria a Dio e manifestano
l'accoglienza negli altri, a somiglianza di quella che ha avuto
Gesù per tutti noi.
|
 Lc
6, 27-38 Lc
6, 27-38
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi che ascoltate, io
dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti
percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello,
non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le
cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a
voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se
fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è
dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui
sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa
sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli
ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non
sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Luca 6,27-38
Nel suo Vangelo Luca riprende le linee che Matteo ha
formulato nel "discorso delle beatitudini" (cap5-7). C'è molta folla,
racconta Luca, che cerca Gesù, e "il discorso della Pianura" è rivolto ai
discepoli. I messaggi di Gesù sono splendidi ma esigono una premessa: "Queste
parole sono per chi ha scelto il Maestro e quindi, nonostante i malumori e i
limiti personali, se ci si è fatti discepoli di Gesù non ci si mette a
discutere sul valore di una Parola di conversione, ma, al limite, si dichiara
la propria difficoltà a capire e la richiesta di chiarimento e di forza. La
dimensione fondamentale di Dio, in Luca, è la sua misericordia e tutto il
testo che leggiamo oggi va riletto sotto questo profilo.
Il testo di oggi
comincia con quattro imperativi: "Amate, fate del bene, benedite, pregate".
Ci ritroviamo con scelte e stili di vita che rifiutano totalmente la
violenza. La violenza non costruisce nulla, ma cancella prospettive di
crescita poiché la violenza schiaccia, contrappone, scatena gli odi mentre fa
sentire la debolezza come una maledizione e fa sognare la potenza di
sopraffarlo l'altro, di poterlo uccidere. La violenza risveglia volontà di
violenza, a sua volta, e di rivalsa. Gesù non chiede che si diventi amici,
nel senso della condivisione nella simpatia. La simpatia non dipende da noi e
non può essere comandata. Gesù chiede di amare, cioè di preoccuparsi dei
bisogni dell'altro.
Non siamo solo nell'atteggiamento di non rispondere al
male con il male, alla violenza con la violenza ma si tratta di accogliere e
quindi è necessario avere il coraggio di fare il primo passo per aiutare
l'altro ad uscire dalla incapacità a sperare un cambiamento, supposto lo
voglia aspettare. |