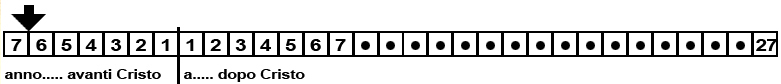
Circoncisione del Signore
1 gennaio 2022
Lc 2, 18-21
Riferimenti:Nm 6, 22-27 - Sal 66 - Fil 2, 5-11 |
Dio ci benedica con la luce del suo volto. Dio abbia
pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo
volto; perché si conosca sulla terra la tua via, la tua
salvezza fra tutte le genti
|
|
Nm 6, 22-27
In quei giorni. Il Signore parlò
a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli
dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: direte
loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il
Signore faccia risplendere per te il suo volto e
ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo
volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio
nome sugli Israeliti e io li benedirò».
Numeri 6, 22-27
Nel libro dei Numeri
(6,22-27), come augurio per l'anno nuovo, ci
viene ricordata la benedizione sacerdotale,
voluta da Dio e limitata ad Aronne e alla sua
discendenza. Secondo la tradizione rabbinica,
questa formula veniva pronunciata per la
benedizione del popolo, ogni giorno, dopo il
sacrificio della sera. Ci sono molti richiami
con le preghiere dei salmi. Il testo della
benedizione è ordinato in 3 strofe al centro
delle quali viene ricordato il nome divino di
Javhè (tradotto qui come Signore), anche se
allora mai pronunciato, ma sostituito con altri
nomi.
Dio è la fonte di ogni benedizione.
La formula nell'originale ebraico ha 3 parole
nella prima strofa', 5 nella seconda e 7 nella
terza. Dio si fa presente, esiste accanto,
accompagna. Le invocazioni domandano che Javhè
sia davvero Javhè per Israele e doni, prima, se
stesso e poi ì suoi benefici.
Dio mostri la
sua presenza favorevole accanto a Israele. Si fa
riferimento al concreto benessere.
Possiamo
ricordare Deut 28,1- 13 o il testo Gen 1,28 dove
la benedizione è legata alla fecondità o
all'affido del governo del mondo all'uomo.
Questo testo richiama anche l'efficacia della
Parola di Dio (Is 55,10-11) che produce quanto
pronuncia.
"Dio faccia brillare il suo volto
" non significa tanto: "il Signore sorrida ma il
Signore ti faccia percepire la sua presenza e
personalità (volto) e ti faccia gustare quanto è
illuminante e rassicurante il rapporto con Lui".
E'richiamo di accoglienza e benevolenza.
"Javhè elevi a te il suo volto": vien chiesto un
rapporto stabile con il suo popolo poiché da qui
scaturisce la pace. Quando il volto di Dio è
nascosto, la miseria ed il disagio sorgono
profondi. Viene richiesto lo sviluppo armonico e
felice, opera messianica per eccellenza (Is
9,1-6). Porre il nome (v 27) richiama le mani
protese verso il popolo nel gesto della
benedizione (1 Re 8,51).
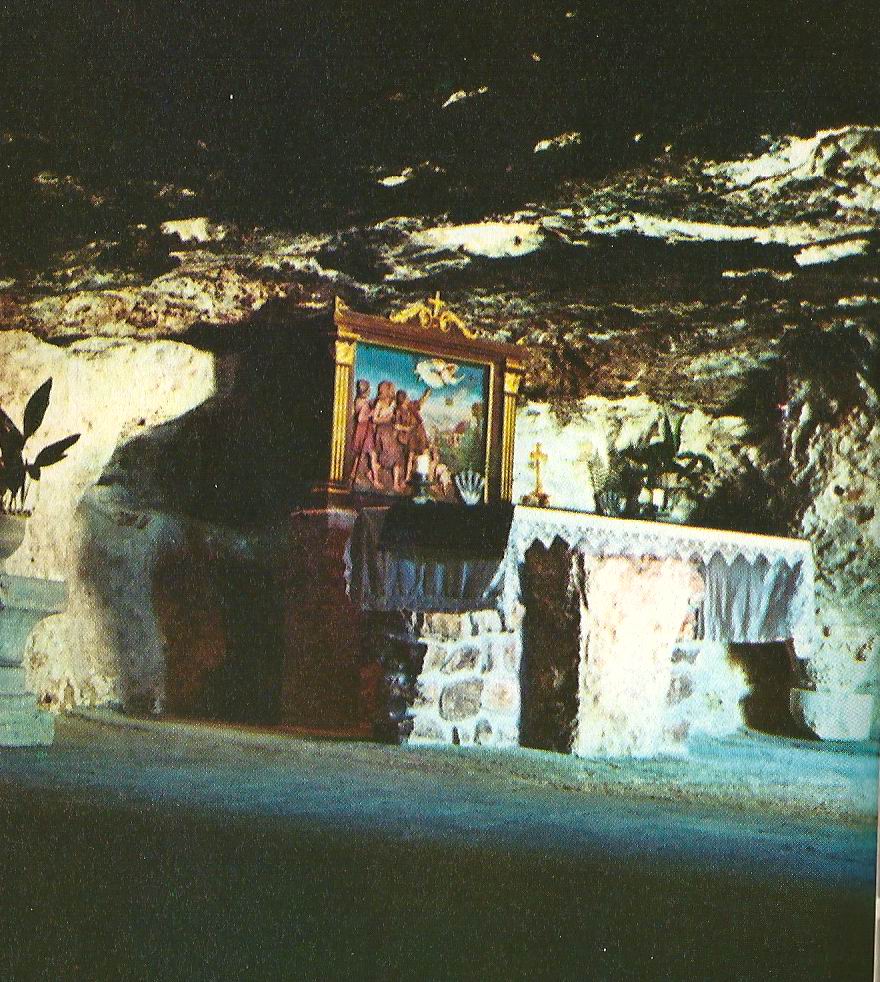
Bethlemme: una grotta ove i pastori
passavano le notti invernali |
Fil 2, 5-11
Fratelli, abbiate in voi
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a
una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni
lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio
Padre.
Filippesi 2, 5-11
Paolo sta sperimentando un
cammino impensabile solo pochi decenni prima: egli sta operando
nel nome di Gesù una convergenza di popoli nella umanità intera.
Giudei e pagani (detti "gentili" da "le Genti") si ritrovano
insieme, riconciliati in Gesù e quindi in pace tra loro, con la
stessa dignità e la stessa figliolanza con Dio. Per un segno
nella carne (la circoncisione: l'espressione dell'Alleanza) che
non hanno, i Gentili sono stati esclusi dalla cittadinanza di
Israele e dalle promesse dell'Alleanza stessa. E questo ha tolto
loro l'accesso ai doni di Dio e quindi alla salvezza.
Tra i
due popoli non c'era comunicazione, tanto che anche solo un
semplice passaggio di cortili del tempio, superando il muro di
separazione che divideva i circoncisi dai pagani, sarebbe stato
punito con la morte.
"Eravate senza Cristo, esclusi dalla
cittadinanza d'Israele, estranei ai patti della promessa, senza
speranza e senza Dio nel mondo".
Si parla di cittadinanza
e di patti della promessa.
- La cittadinanza era un
privilegio politico molto importante: essa oltrepassava i
confini territoriali e Roma offriva, per meriti particolari,
cittadinanza romana anche a degli stranieri. Paolo era un
custode fiero e geloso della sua cittadinanza romana che lo
salvò molte volte da processi, linciaggi e prigioni. E sapeva
molto bene il valore di sentirsi, insieme, cittadini di un
popolo.
- "I patti della promessa" si richiamano a fatti
operati dai Patriarchi e dal Popolo condotto da Mosè, escludendo
i pagani che sono cittadini di un mondo senza Dio, con idoli
muti che non comunicano la loro volontà né la loro salvezza.
Cristo ha fatto un popolo solo con il suo sangue e si è
sottoposto nella sua umanità ai precetti di quella medesima
legge fino a subirne la maledizione: "Cristo ci ha riscattati
dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione
per noi, poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno,
perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai
pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello
Spirito (Gal3,13-14)". Così Gesù ha distrutto ogni inimicizia
tra Dio e gli uomini e negli uomini tra loro.
|
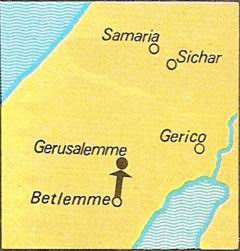 Lc 2, 18-21
Lc 2, 18-21
In quel tempo.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli
otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era
stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Luca. 2,
18-21
Il breve testo del Vangelo collega l'incontro dei pastori la notte
di Natale nella grotta in cui Gesù è nato e i gesti squisitamente ebraici che
inseriscono Gesù nella storia del popolo d'Israele mediante la circoncisione.
Al centro c'è la rivelazione dello stile della Madonna, atteggiamento di
ricerca, di contemplazione, di ubbidienza costruttiva e appassionata che
dovrebbe corrispondere all'atteggiamento della comunità cristiana, che trova
in Maria il suo modello: "Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore." Il messaggio inizia dalla parola che i pastori
portano: sono gli ultimi arrivati, sono i poveri, gli esclusi dalla comunità
ebraica, anche se non poveri economicamente, e sono coloro che hanno ciò che
è importante offrire. Essi comunicano il messaggio di Dio su questo bambino
che è speranza per tutti e coinvolgono persino i protagonisti del mistero:
Maria e Giuseppe. Le cose che essi affermano suscitano stupore. Si può
certamente dire che essi "dicono la buona novella" e questo suscita
sbalordimento perché il mondo di Dio si apre su tutti come speranza, come
accoglienza, come progetto di vita nuova, come popolo che ricongiunge insieme
tutte le realtà, superando le lacerazioni o le contrapposizione.
L'atteggiamento di chi scopre con meraviglia che Dio manda segni per la
speranza di tutti e di ciascuno matura in un ascolto umile e privilegiato: un
ascolto in silenzio, che raccoglie i richiami e le ricchezze, i miti, i
racconti e la storia del proprio popolo. Tutto questo è materiale che va
raccolto, meditato, capito ogni giorno nella propria interiorità. Il cuore,
nel mondo ebraico, viene inteso come la dimensione più profonda
dell'intelligenza e dell'accoglienza di ciò che Dio dice.
Maria non si
preoccupa di parlare, ma di ascoltare, attenta a riempire di risposte quegli
interrogativi che continuamente sono sorti in lei e in Giuseppe. E proprio a
Betlemme sono all'oscuro di tutto.
|